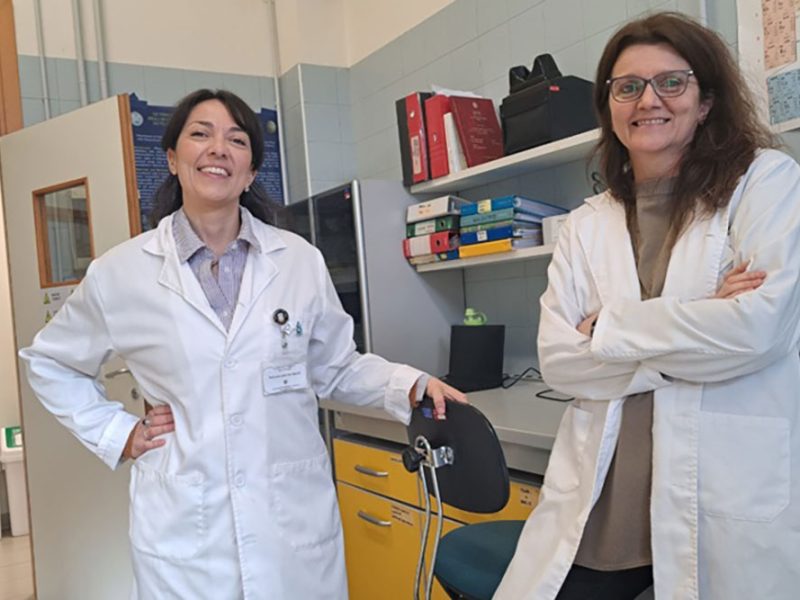Energie rinnovabili, il punto in Italia
 MILANO – In attesa che da Bruxelles arrivino notizie di “correzioni” o meno della politica ambientalista impostata dalla precedente commissione UE, l’Italia sta facendo il punto sulla sua dotazione di strumenti per la produzione di energia rinnovabile.
MILANO – In attesa che da Bruxelles arrivino notizie di “correzioni” o meno della politica ambientalista impostata dalla precedente commissione UE, l’Italia sta facendo il punto sulla sua dotazione di strumenti per la produzione di energia rinnovabile.
In testa nel passato grazie alla sfruttamento dell’energia idrica – invasi e dighe sono state per decenni il nostro investimento di punta, ovviamente al nord ma non solo – c’è voluto qualche tempo per fare partire i meccanismi dei nuovi sistemi, sia dell’eolico che del solare. Non tanto per lo scetticismo sul nuovo – peraltro alcuni esperimenti in larga scala, come l’elettrificazione con pannelli solari dell’isola di Gorgona sul Tirreno si sono dimostrati un fallimento – tanto sulle resistenze anche dei tutori del paesaggio alle istallazioni. San cosa oggi le Soprintendenze ai monumenti fanno resistenza ad accettare che su borghi antichi, o sulle isole, possano essere istallati estesi campi di pannelli: tante più resistenze alla istallazione dei pannelli solari sui tetti delle vecchie case, per non parlare della lunga, defatigante serie di adempimenti burocratici.
* * *
Malgrado tutto ciò, la conversione green della produzione elettrica è in atto anche nel nostro paese. Secondo il recente rapporto del Politecnico di Milano (Renewable Energy Report 2024) l’anno scorso è stato l’anno record per l’istallazione di impianti di energia verde. Sono stati messi in funzione ben 5,7 gigawsatt, di cui 5,2 relativi al fotovoltaico, che hanno portato l’istallato complessivo alla soglia dei 70 gigawatt, una soglia mai raggiunta se si pensa che solo nel 2021 eravamo a 1,3 gigawatt e l’anno dopo eravamo saliti a 3 gigawatt. Siamo ancora lontani dalla sogli ideale proposta dal piano nazionale integrato per Energia & Clima, che comporta un aumento annuo di almeno 9 gigawatt per arrivare all’obiettivo di decarbonizzazione del 2030, ma c’è comunque la dimostrazione che l’Italia non sta con le mani in mano sul tema.
[hidepost]
* * *
Perché siamo in ritardo, anche rispetto a Nazioni che hanno condizioni meteo e di insolazione già negative? Secondo lo studio di Energy&Stategy della School& Management milanese, la prima difficoltà è legata proprio alla burocrazia, che rende lunga e faticosa la trafila degli atti per ottenere i permessi di istallazione, per i controlli ai lavori e per il definitivo nulla osta all’attivazione. Qualcosa sta migliorando, ma non molto.
Poi c’è il problema del suolo. I pannelli solari sui tetti possono fornire energia ai singoli fabbricati: ma per arrivare a potenze da riversare in rete occorrono estesi campi di pannelli, che “consumono” territorio, spesso in concorrenza con le coltivazioni o con gli altri utilizzi del suolo. La stessa orografia del nostro suolo non aiuta a reperire grandi aree “pannellabili” che non siano sottratte all’agricoltura. Anche le tariffe di remunerazione per chi sarebbe disposto a mettere a disposizione aree adatte non sono adeguate, come stanno dimostrando le aste bandite da molte regioni. Morale: gli impianti di grandi dimensioni non crescono, il costo dei pannelli oscilla troppo, e non aiuta nemmeno la consapevolezza che buona parte di quelli offerti sul mercato sono di produzione cinese, il che lascia sempre qualche sospetto su qualità e durata.
* * *
Rimane sospeso il giudizio sull’eolico, che nel 2023 ha prodotto solo 500 megawatt nel totale di 5,7 gigawatt: poco più di una manciata di energia. Perché, così poco, visto che in paesi del nord Europa (per non andare oltre) l’eolico è arrivato a produrre più del fotovoltaico?
Le risposte sono, come sempre, articolate: una “torre” eolica costa cara, richiede più manutenzione di un campo fotovoltaico, e sul piano paesaggistico suscita spesso l’opposizione del territorio. Per ovviare, si sta sviluppando, speciecialmente nella parte sud della penisola, il ricorso all’eolico sul mare: nel golfo di Taranto, come in Sicilia, Sardegna e sulle coste tirreniche, ci sono in atto lavori – di cui le imprese italiane sono all’avanguardia per enologie e addetti – che dovrebbero mettere in servizio entro un anno svariati megawatt. Gli impianti sul mare sono di due tipi: o ancorati su alti fondali, grazie a piattaforme galleggianti a prova di uragani: o su basi piazzate sul fondale marino, dove però il fondale è modesto, ovvero su non più di 20/30 metri. Servono le secche, le scogliere affioranti, i bassofondi. Tutte realtà che lungo le coste non mancano. Anche in questo caso un certo ambientalismo NISBY è schierato contro in nome del paesaggio. E la lotta continua. (A.F.)
[/hidepost]