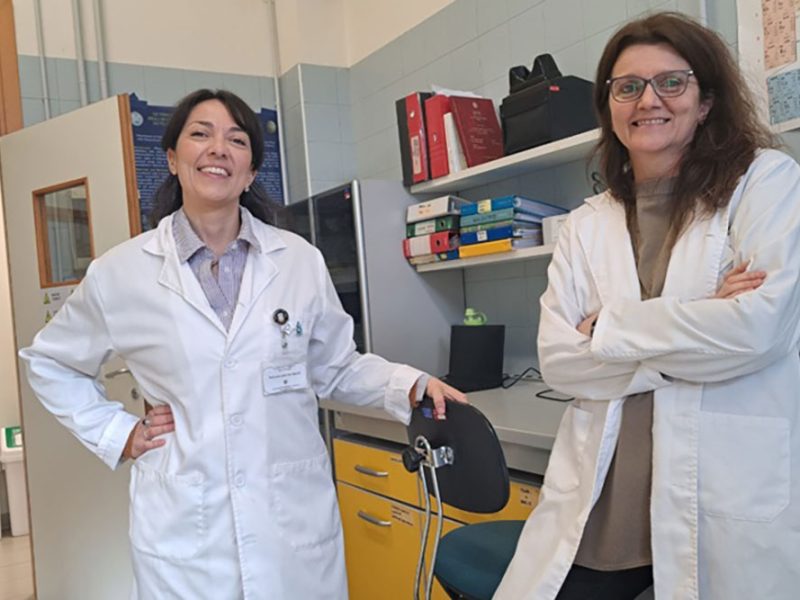Laurearsi è 4 volte più probabile per chi ha un genitore laureato
Una generazione mandata al macello. Ma il Sant’Anna: no, è possibile fare molto a patto che…

PISA. Nel nostro Paese se tuo padre o tua madre si è laureato hai più del quadruplo di possibilità di arrivare a laurearti anche tu rispetto a chi ha i genitori che non sono riusciti a raggiungere nemmeno il diploma. Parrebbe la scoperta dell’acqua calda ma non è così inutile tornare a sottolinearlo: appartiene a quei fenomeni sociali che sono talmente sotto gli occhi di tutti da diventare peggio dell’ “elefante nella stanza”: evidenti eppure invisibili. Come se gli ingranaggi dell’uguaglianza fossero davvero in funzione, e invece così non è: «In Italia il 63% dei giovani adulti con almeno un genitore laureato conclude a sua volta un percorso universitario, contro appena il 15% di coloro i cui genitori non hanno completato la scuola secondaria superiore». Parola dell’équipe della Scuola Superiore Sant’Anna, istituzione universitaria d’eccellenza che ha il quartier generale a Pisa: eppure…
Il team santannino prende i dati dal report dell’Ocse “Education at a Glance 2025” per segnalare che «la mobilità educativa intergenerazionale resta limitata in tutti i Paesi: i giovani adulti (25-34 anni) hanno una probabilità significativamente maggiore di conseguire un titolo universitario se anche i loro genitori lo hanno fatto». Tradotto: altro che eguaglianza delle opportunità, macché tutti allo stesso livello ai nastri di partenza e poi chi ha più filo da tessere grazie al proprio talento più tesserà la tela. Il verdetto è chiaro: «L’istruzione continua a trasmettersi di generazione in generazione: chi nasce in famiglie meno istruite incontra ancora barriere significative nell’accesso alle opportunità formative».
Questa diseguaglianza è maggiore in Italia che altrove: il divario è di 48 punti percentuali nel nostro Paese, nel resto delle aree Ocse (cioè quello che definiamo Occidente a economia avanzata o perlomeno quasi). Il rapporto Ocse indica che la quota di giovani adulti (25-34 anni) che non è riuscita a conseguire il titolo secondario superiore «continua a diminuire in tutta l’Ocse, raggiungendo una media del 13%». L’Italia se la cava un po’ meglio, ma anche qui da noi il calo è rilevante: giù «dal 24% al 19% tra il 2019 e il 2024».

La tabella è tratta dall’indagine Ocse “Education at a glance 2025”>:mostra, paese per paese, la percentuale di studenti universitari che hanno alle spalle una famiglia in cui nessun genitore ha conseguito il diploma e, più chiaro, in color grigio, la percentuale di chi invece fra loro ha dietro una famiglia con almeno un genitore laureato o con titolo equipollente
Ma se il Sant’Anna acchiappa questo dato è per rilevare che si può tentare di dare una svolta: certo, il requisito fondamentale è che bisogna prendere a riferimento un gruppo sociale di studenti selezionato sulla base del merito scolastico. Dunque, si comincia partendo da quelli bravi, anzi bravissimi se è vero che si tratta di quanti partecipano al corso di orientamento in entrata a scuole d’eccellenza. Eppure, fatte queste premesse, un dato incoraggiante c’è: bisogna che i ragazzi e le ragazze se lo costruiscano quasi da soli, contando magari sulle proprie doti e la propria abnegazione (e magari qualche prof particolarmente bravo e/o disponibile).
Stiamo parlando del progetto “Memo”, sigla che sta per “Merito e Mobilità Sociale”: nasce – viene sottolineato – grazie all’impegno congiunto delle cinque scuole universitarie della rete “Merita” in cui insieme al Sant’Anna figurano la Scuola Normale Superiore, la Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova, il Collegio Superiore dell’Università di Bologna e la Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza dell’Università di Roma. È finanziato con il Pnrr e ha visto la partecipazione di oltre 600 studenti del penultimo anno delle scuole superiori, tutti «provenienti da famiglie senza precedenti universitari e selezionati unicamente in base al merito scolastico». Risultato: sceglie di iscriversi all’università il 90% dei ragazzi che partecipano al percorso di orientamento, è una percentuale «significativamente più alta rispetto alla media Ocse».
Per questa schiera di studenti bravi a caccia di un futuro tutto da scrivere grazie al loro talento si sono «appena conclusi gli incontri residenziali presso le istituzioni partner, momenti intensivi di formazione e confronto pensati per rafforzare competenze, aspirazioni e opportunità».
Le cinque scuole universitarie superiori della rete “Merita” – cinque super-atenei presenti nel nostro Paese – hanno messo nero su bianco una dichiarazione per sottolineare che «i dati Ocse dimostrano che l’Italia ha ancora molta strada da fare per garantire pari opportunità ai giovani, indipendentemente dal contesto familiare». Ricordato che il progetto “Memo” punta a scovare i talenti di chi non viene da famiglie di laureati, si sottolinea il risultato come un risultato già assai positivo il fatto che, come detto, si iscrivano all’università nove studenti meritevoli su dieci fra quanti hanno genitori senza precedenti universitari («la strada intrapresa è quella giusta»). Ma c’è un salto da fare ora: trasformare “Memo” da progetto sperimentale a sistema stabile e diffuso, Serve «l’impegno congiunto di tutte le istituzioni».

Foto di gruppo al Sant’Anna per i protagonisto del proogetto Memo
Gli istituti della rete “Merita” spendono un ringraziamento per il ministero dell’istruzione e del merito («con cui è attivo un protocollo di intesa») e il ministero dell’università e della ricerca («ha messo a disposizione le risorse Pnrr per finanziare la rete “Merita”»). Aggiungendo: «Il loro sostegno è stato decisivo in questa fase di avvio ed espansione, è ora fondamentale continuare a lavorare insieme affinché la mobilità sociale diventi una priorità permanente per il Paese».
Al di là di questa posizione del fronte delle scuole d’eccellenza, forse può essere utile dare un’occhiata all’indagine Ocse sui sistemi di formazione: non ne usciamo benissimo. Sia chiaro, è un po’ in tutto l’Occidente che si registra quest’abbassamento di competenze e di titoli: in gran parte dei Paesi Ocse una percentuale rilevante di adulti ha «bassi livelli di competenza di alfabetizzazione», vengono definiti “livello 1 o inferiore” su una scala che va da zero a 5. Stiamo parlando di persone in grado di capire bene «solo testi molto brevi con informazioni minime che possano distrarli». Tenetevi forte: in qusto report si segnala che non nell’ultimo staterello in mezzo al nulla bensì in Italia, una delle prime sette economie mondiali, «il 37% dei giovani tra i 25 e i 64 anni ha competenze di alfabetizzazione pari o inferiori al livello 1»: cioè assai peggio della media Ocse (27%).
C’è dell’altro: ad esempio, le cose stanno peggiorando. L’indagine Ocse lo dice mettendo a confronto la prima metà dello scorso decennio (2012-2015) e la situazione grossomodo attuale (2023). Risultato: in Italia lo standard di punteggio di alfabetizzazione per un adulto laureato è, in quest’arco di tempo, diminuito di 10 punti, quello per chi non ha neanche il diploma è sceso di di 14 punti.
Quanto ai tempi di completamento degli studi universitari, la ricerca internazionale dice che in Italia il 37% degli studenti ce la fa a laurearsi rimanendo in pari con la durata prevista del proprio corso (media Ocse 43%), si arriva al 51% (59% nell’Ocse) se si considera buono anche un anno di ritardo e al 56% se si mette nel conto chi ce la fa entro tre anni (70% negli altri Paesi “occidentali”).
Sembra di vedere l’identikit di una generazione mandata al macello dalle strategie educative e dagli effetti delle diseguaglianze sociali. Oltretutto si perpetueranno: i dati Ocse misurano con una sfilza di percentuali e numeri l’effetto che il livello di istruzione ha sulla probabilità di restare disoccupati, sulla facilità di esser costretti a cavarsela con lavoricchi precari, su quanti soldi in busta paga e via dicendo.
Vale la pena di segnalare anche l’atteggiamento di ragazzi e ragazze di fronte alla mobilità internazionale degli studenti universitari: complessivamente è cresciuta al 7,4% rispetto al 6% del 2018. In Italia no: è «uno dei pochi Paesi in cui in questo campo non c’è nessun aumento», anzi si scende «dal 5,6% al 4,8%».
L’ultima fra le mille sottolineature possibili riguarda gli stipendi effettivi medi degli insegnanti della primaria: dal 2015 la media dei Paesi Ocse dice che sono «aumentati in termini reali del 14,6%», al contrario di quanto accaduto in Italia (meno 4,4% nel 2024).
Mauro Zucchelli