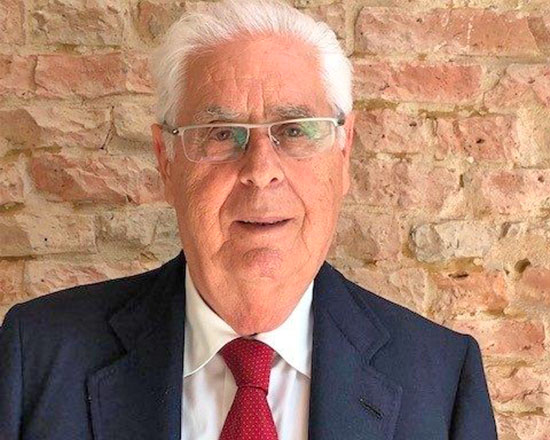Vecchie navi, nuovi problemi: lo smaltimento a fine vita
Se, come ha scritto di recente Mauro Zucchelli su queste colonne, le navi moderne (e del futuro prossimo) avranno una configurazione architettonica e una fisionomia differente rispetto alle attuali, ciò significa che il processo di dismissione delle imbarcazioni considerate obsolete sarà ancora più accelerato rispetto a quanto sta avvenendo oggi. Mezzi più aerodinamici, meno inquinanti e meno energivori sono ormai la grande sfida degli armatori più innovativi. Dietro questa svolta, però, la questione ambientale incombe: ci sarà da smaltire una quantità di navi, di tutte le taglie e dimensioni, impressionante, senza che vi sia, al momento, un piano globale per come affrontare questa ennesima emergenza ecologica.
Lo smaltimento oggi
Quando una nave non può essere più utilizzata (dopo circa 30 anni di vita) e neanche riciclata in qualche modo, è necessario smaltirla, come avviene per qualunque tipo di rifiuto. Occorre, insomma, procedere allo “shipbreaking”, che di solito viene compiuto in uno spazio di tempo variabile dai 2 ai 5 mesi. Il procedimento è complesso, e occorrono strutture adeguate affinché ciò sia fatto in sicurezza, per l’ambiente così come per i lavoratori addetti a tale compito.
Vi sono 7 fasi principali per lo smaltimento di imbarcazioni vetuste: in primo luogo, la nave viene di solito spiaggiata, poi decontaminata dalle varie sostanze tossiche eventualmente presenti, quindi occorre procedere alle smantellamento strutturale delle sue parti superiori, compreso il ponte, gli alberi e le altre strutture sopra il ponte; a questo punto la nave è pronta per procedere allo smantellamento delle strutture interne, dove gli addetti devono penetrare per rimuovere attrezzature quali macchine, componenti elettroniche, ecc. La quinta tappa consiste nel taglio dello scafo; questa operazione richiede cannelli ossidrici e macchinari pesanti. I segmenti che risultano dall’operazione di taglio possono essere venduti o ulteriormente fusi. Le ultime due tappe consistono nella separazione dei materiali da riciclare (metalli, plastica, legno, ecc.) e nel rimuovere dal sito le parti rimanenti, spesso lo scheletro della nave.
Le convenzioni internazionali e gli impianti autorizzati
In ogni caso, anche quando il procedimento è compiuto in modo impeccabile, i rischi di inquinamento ambientale e quelli per la salute degli operatori sono elevati. Come è stato scritto in un report dell’Ilo (International Labour Organization) risalente all’anno 2000, al di là dell’impatto ambientale, il numero di incidenti mortali, ferimenti gravi e malattie da lavoro sembrano rappresentare la caratteristica principale delle operazioni di smaltimento delle navi.
Dal 1994 al 2002 il 15% della forza-lavoro indiana ha sviluppato il mesotelioma, un cancro che colpisce le cellule del mesotelio, e che ha provocato 4.513 casi su 31.000 lavoratori impegnati nell’attività di smaltimento delle navi. Per ovviare a tutte queste problematiche, nel 2009 è stata approvata una specifica convenzione (la Convenzione di Hong Kong per il riciclaggio sicuro delle navi e nel rispetto dell’ambiente, sotto l’egida dell’International Maritime Organization, Imo), spingendo i grandi armatori ad assumere, nelle loro politiche corporative, lo smaltimento sostenibile delle imbarcazioni come pratica usuale (Green Ship Recycling).
La Convenzione, però, entrerà in vigore solamente quest’anno, poiché una delle sue clausole prevedeva che un minimo di 15 stati membri dell’Imo con tonnellaggio commerciale pari almeno al 40% del totale mondiale vi aderisse. Circostanza che si è verificata solamente nel 2023, quando Bangladesh e Liberia hanno compiuto il grande passo.
A livello di Unione Europea, nell’aprile del 2010 è stato dichiarato che la Convenzione di Hong Kong assicura un livello di controllo e di smaltimento non inferiore rispetto ai principi della Convenzione di Basilea del 1989 sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi, cosicché le parti firmatarie di tale convenzione, nel 2011, hanno incoraggiato i vari stati ad aderire alla Convenzione di Hong Kong. Ancora in ambito Unione europea, nel 2007 è stato approvato un Libro Verde per la migliore demolizione delle navi, con una normativa che identifica una serie di porti e cantieri formalmente autorizzati.
Con la Decisione della Commissione Ue 2016/2323, sono stati identificati gli impianti di riciclaggio delle navi in ambito comunitario (https://www.certifico.com/component/attachments/download/4246). Si tratta di 18 impianti, a cui vanno tolti, oggi, i tre appartenenti al Regno Unito, sparsi fra vari paesi, in cui non figura alcun porto o cantiere italiano. In seguito all’approvazione, da parte della Capitaneria di Genova, del primo piano italiano di demolizione sostenibile di una nave nel 2021, l’impianto di San Giorgio del Porto è stato autorizzato a effettuare operazioni di smaltimento navale. Come è successo, per esempio, per le ex-barche “Porta”, da tempo dismesse e stazionate presso l’area delle riparazioni navali dello scalo genovese: quattro mezzi demoliti, col recupero di 1.475 tonnellate di acciaio e ferro, 970 tonnellate di cemento avviate al recupero 150 metri di banchina liberati (qui il link alla notizia d’attualità).
Una grande operazione, che tuttavia non deve nascondere quanto solitamente avviene per lo smaltimento delle grandi navi, a partire da quelle italiane (a parte Costa Concordia, che fu demolita nei cantieri di Genova): Bangladesh, Pakistan, Turchia, Cina (che però dal 2018 ha vietato le importazioni di navi da smaltire), India, Namibia sono gli stati che, per costo di manodopera e scarso rispetto delle normative ambientali e del lavoro, risultano maggiormente appetibili per operazioni a carico di armatori e, eventualmente, assicurazioni.
Il sub-continente indiano nel business dello smaltimento navale
È quindi il sub-continente indiano, insieme ad altri Paesi emergenti, a farla da padrone rispetto allo smaltimento delle grandi navi, provenienti per circa il 40% da mercati europei, Grecia e Germania in primo luogo. Ciò avviene grazie ad operazioni commerciali note come “bandiera di convenienza”, permettendo alle grandi imprese marittime mondiali di mascherare la nazionalità dell’imbarcazione, per esempio registrandola in stati come Panama o le Isole Marshall, eludendo regole e trattati internazionali sempre più stringenti, e andando a smaltire in Paesi poco sicuri, con notevoli risparmi.
Il mercato dello smaltimento, secondo dati del 2023, vale circa 4 miliardi di euro. Secondo dati di Shipbreaking Platform, ogni anno un migliaio di navi viene demolito, anche se i dati, negli ultimi tempi, sono scesi, attestandosi su circa 500 navi dismesse, contro le oltre 1.200 dei primi anni del decennio scorso.
La questione centrale riguarda le modalità con cui lo smaltimento avviene: di solito, senza alcun rispetto per regole ambientali e lavorative, in considerazione dei paesi che detengono il monopolio della dismissione navale. Una questione che ha più volte toccato anche compagnie ben note in Italia: la svizzera Msc, per esempio, è stata duramente criticata da Shipbreaking Platform per avere smaltito un centinaio di navi, negli ultimi anni, proprio in Asia Meridionale, di cui 9 nella spiaggia di Alang, nello stato di Gujart, dove si trova il più grande impianto di smaltimento al mondo (qui il link alla notizia su “Shipping Italy”).
Qui, quasi la metà di tutte le navi viene demolita (capacità annuale di smaltimento di 4,5 milioni di LDT, circa 30mila posti di lavoro creati). Insieme a Bangladesh e Pakistan, l’India controlla l’80% di questo mercato mondiale. La concorrenza, tuttavia, è elevatissima: l’India, che sta stentando ad adeguarsi, a livello tecnologico, per effettuare queste complesse operazioni rischia di lasciare spazio a paesi come Pakistan, Bangladesh o Turchia, fortemente impegnati nel ritagliarsi importanti fette di questo mercato. I rischi, però, sono all’ordine del giorno. Soprattutto per queste ragioni la Cina ha molto limitato questa attività nel proprio paese, almeno rispetto a navi straniere.
Eredità pesanti
Oltre il 90% del commercio mondiale passa da traffici marittimi. Se, oggi, pur se con estreme difficoltà, il settore dello smaltimento navale sta cercando di darsi normative e regole per tutelare sia l’ambiente che la salute dei lavoratori, in passato il quadro era del tutto diverso. E la sua eredità pesa ancora oggi.
Vi sono luoghi della terra che sono ormai considerati veri e propri cimiteri navali, e il cui recupero è praticamente impossibile. In qualche caso le navi affondate hanno creato ecosistemi ormai stabilizzatisi, a cui flora e fauna si sono perfettamente adattate. Come, ad esempio, presso la Laguna di Chuuk, completamente sott’acqua, che ospita una sessantina di navi da guerra giapponesi nel Pacifico Sud, a suo tempo abbattute da attacchi alleati.
Diverso e più tragico è il caso del Lago d’Aral, dove il governo sovietico decise di tagliare i rifornimenti idrici dei due fiumi che alimentavano l’allora Mar d’Aral, prosciugandolo e obbligando i proprietari delle varie navi ad abbandonarle. Ancora oggi, esse si trovano a cielo aperto, completamente lasciate a se stesse, in un paesaggio spettrale e altamente inquinato da vari materiali in decomposizione.
Ma anche nelle acque del Mediterraneo l’eredità di smaltimento di “navi dei veleni” è pesante. Fra i documenti desecretati nel 2017, su richiesta dell’allora presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il ferrarese Alessandro Bratti (Pd), appena nominato nuovo Coordinatore Generale dell’International Network of Basin Organizations (qui il link alla notizia), vi sono notizie dettagliate da parte dell’intelligence italiana di un affondamento di una novantina di navi nel Mediterraneo, fra il 1989 e il 1995, contenenti rifiuti pericolosi o radioattivi. E (nel 2003) un report del Sismi alla presidenza del consiglio riguardante il trasporto a Mogadiscio di due navi cariche di rifiuti industriali e sostanze tossiche, evoca quanto accaduto a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin propria in terra somala (qui il link alla notizia su “Fanpage”).
Un’eredità, anche questa, molto pesante, in termini ambientali ma anche morali, a cui forse, un giorno, le autorità italiane sapranno rispondere con cognizione di causa.
Luca Bussotti
(Luca Bussotti è africanista, docente universitario in Mozambico, Portogallo e Brasile, oltre a essere visiting professor in atenei italiani quali Milano e Macerata)