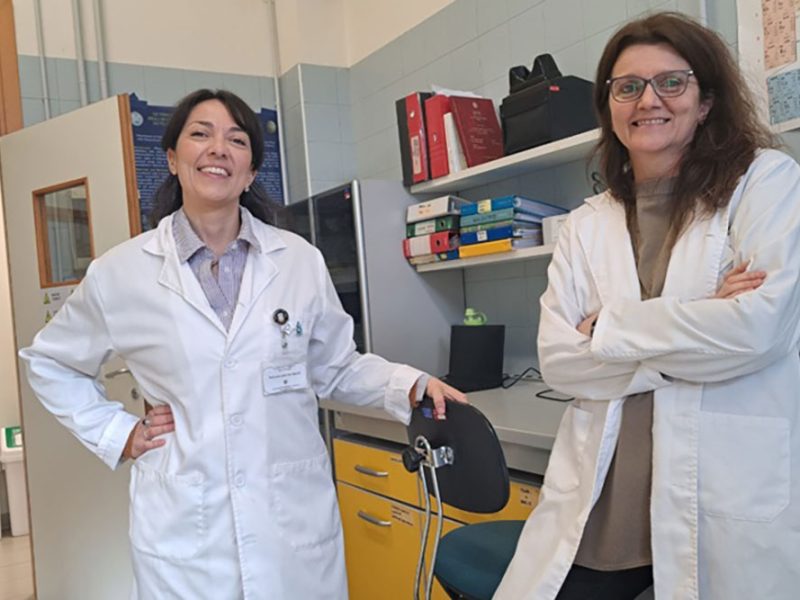Anche gli etruschi soffrivano di mal di denti: era parodontite
L’indagine dell’Università di Pisa sui resti provenienti da sei necropoli
 PISA. È possibile che la notizia non vi consoli granché se avete le gengive infiammate, ma anche le popolazioni sia etrusche che sannite – quel grumo di popoli che affollavano la scena della penisola prima dell’ascesa del potere di Roma – soffrivano di mal di denti: segnatamente, di parodontite. Colpa non solo di scarsa igiene orale, ma anche di abitudini alimentari. Lo dice uno studio dell’Università di Pisa compiuto in tandem con gli atenei di Zurigo e Basilea: l’indagine è stata pubblicata sul “Journal of Proteomics”.
PISA. È possibile che la notizia non vi consoli granché se avete le gengive infiammate, ma anche le popolazioni sia etrusche che sannite – quel grumo di popoli che affollavano la scena della penisola prima dell’ascesa del potere di Roma – soffrivano di mal di denti: segnatamente, di parodontite. Colpa non solo di scarsa igiene orale, ma anche di abitudini alimentari. Lo dice uno studio dell’Università di Pisa compiuto in tandem con gli atenei di Zurigo e Basilea: l’indagine è stata pubblicata sul “Journal of Proteomics”.
Secondo quanto reso noto dall’Università di Pisa, i risultati della ricerca mostrano che «oltre il 20% della dentizione analizzata presentava segni di parodontite», mentre le analisi biomolecolari condotte su 33 campioni di tartaro dentario hanno rilevato «la presenza di proteine specifiche del batterio “Porphyromonas gingivalis”, il principale patogeno responsabile della malattia».
La ricerca ha messo sotto i riflettori, come spiega l’équipe di studiosi pisani, «i resti osteodentari di 63 individui provenienti da sei necropoli etrusco-sannite, incluse Volterra e Tarquinia»: risalgono al periodo tra il settimo e il quarto secolo avanti Cristo. «Lo studio della dentizione per individuare i segni lasciati da infiammazione dei tessuti dentali – viene fatto rilevare – si è accompagnato ad una analisi di “paleoproteomica”, una tecnica innovativa che permette di estrarre e identificare proteine antiche nel tartaro dentario per avere informazioni sullo stato di salute, la dieta e le infezioni delle persone vissute migliaia di anni fa».
È da aggiungere che perle biomagnetiche sono usate per «isolare le proteine dai campioni di tartaro dentario archeologico».
Giulia Riccomi, ricercatrice dell’Università di Pisa e prima autrice dello studio, tiene a mettere in evidenza che «il primo millennio avanti Cristo rappresenta un periodo complesso nella storia dell’Italia: è caratterizzato da importanti trasformazioni socio-economiche tra le comunità preromane. L’emergere di strutture sociali sembra riflettersi in un accesso differenziale alle risorse alimentari: le élite disponevano di una maggiore quantità di carne, mentre le classi non privilegiate basavano la loro dieta prevalentemente sui carboidrati, situazione che in entrambi casi sembra aver favorito l’insorgere di patologie orali che oggi consideriamo tipiche della modernità».
La presenza della parodontite nei resti umani osteoarcheologici non può essere spiegata solo dalla scarsa igiene orale: era «certamente molto diffusa nel passato e fattore cruciale per l’insorgenza della malattia» ma, a giudizio della studiosa, è indispensabile tenere in considerazione i fattori alimentari. «Una dieta ricca di proteine animali e carboidrati fermentabili consumati con alta frequenza, per esempio cereali, pane, zuppe, avrebbe favorito – afferma – squilibri del microbiota orale, alterando l’equilibrio tra batteri “buoni” e “cattivi” del cavo orale e contribuendo all’insorgenza di stati infiammatori cronici e di carie dentali».
Dal punto di vista metodologico, lo studio è una delle poche applicazioni in Italia della paleoproteomica del tartaro dentario antico. Il risultato è stato possibile grazie alla collaborazione con Shevan Wilkin dell’Ancient Protein Laboratory dell’Università di Zurigo, uno dei pochi centri in Europa dotati di strutture dedicate e altamente specializzate per lo studio delle proteine antiche.
“È davvero entusiasmante vedere studi sulla salute degli individui del passato attraverso l’analisi delle antiche proteine. Penso che questo aspetto della ricerca sarà uno dei principali nuovi filoni della disciplina nei prossimi anni”, ha commentato Wilkin.
Il lavoro si inserisce nell’ambito del progetto biennale PROFIT (Pre-Roman Foodways in Italy: an interdisciplinary approach, 2023-2024), finanziato nell’ambito della call Young Researchers MSCA-SoE a Giulia Riccomi e dedicato alla ricostruzione delle abitudini alimentari dell’Italia preromana attraverso una combinazione di paleopatologia dentaria, analisi biochimiche del collagene osseo e biomolecolari di proteomica del tartaro.
Si ringrazia il Museo Civico Archeologico di Bologna, la SABAP-Pisa-Livorno, il Museo Archeologico Nazionale Tarquiniense e il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano per l’accesso ai resti osteoarcheologici esaminati nel progetto PROFIT.