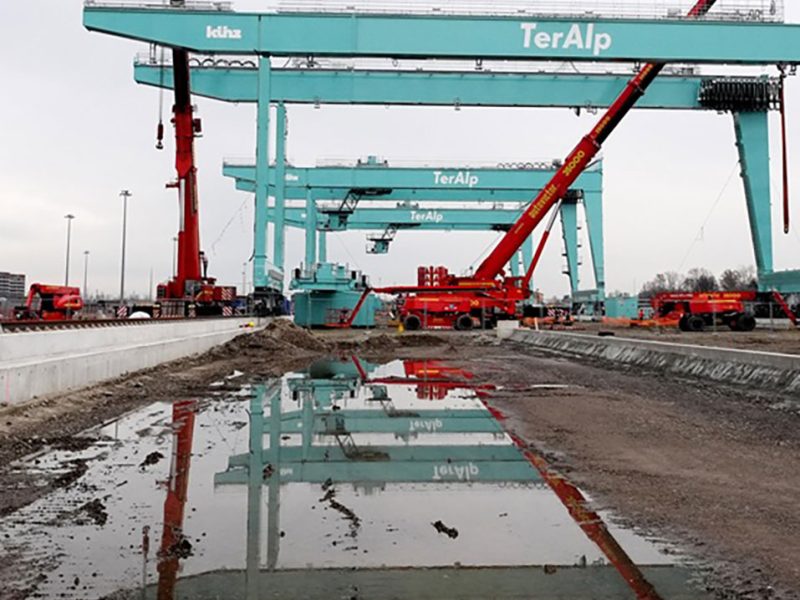L’angolo (del) marittimista – I rifiuti dalle navi nei porti: novità e criticità da risolvere

Luca Brandimarte
Il nostro collaboratore e avvocato 👤 Luca Brandimarte, board legal di Assarmatori, affronta oggi il tema riguardante i 🚯🛳 rifiuti dalle navi nei porti 🚯🛳.
ROMA – Torniamo in argomento sulla “nuova” normativa relativa agli impianti di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/883 (“Direttiva”).
Si tratta del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 197 (“Decreto”), vigente dallo scorso 15 dicembre, avente ad oggetto il “Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE”; Decreto che, lo ricordiamo, ha abrogato il precedente D.Lgs. n. 182/2003.
Le principali novità del Decreto, che in parte riprendono quanto contenuto nella Direttiva, possono dunque essere riassunte come segue.
In primo luogo, tra le definizioni, è stata aggiornata quella di “traffico di linea” da intendersi quale “traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorità competente” (Cfr. articolo 2, comma 1, lett. n)); definizione rilevante, tra le altre, ai fini di un’armonizzazione del regime delle esenzioni per le navi in servizio di linea (con scali regolari e frequenti) di cui all’articolo 9 della Direttiva (e del Decreto) e maggiormente “compliant” rispetto al passato con quanto già stabilito anche dalla giurisprudenza unionale sul tema.
In secondo luogo è previsto che il servizio di raccolta dei rifiuti debba essere erogato in conformità alla legislazione nazionale ed europea vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2017/352 (Cfr. articolo 4, comma 7). Ad avviso di chi scrive, da ciò emergerebbe chiaramente come tale disposizione vada nel senso di non prevedere più: (a) regimi di esclusiva o monopolio in capo ad un unico erogatore di default (ciò quand’anche il servizio fosse definito in sede locale ai sensi della legge n. 84/94 come servizio di interesse generale, come ribadito anche da un’apposita comunicazione della Commissione europea, oltre che in linea con i dettami della giurisprudenza unionale); (b) un obbligo per l’armatore a monte di conferire ad un unico soggetto.
In terzo luogo, viene chiarito per la prima volta che, ai fini della predisposizione del Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, della sua modifica e del suo aggiornamento, nonché della formazione delle relative tariffe, è prevista la consultazione delle rappresentanze dell’utenza a livello nazionale (Cfr. articolo 5, comma 1). Trattasi di un aspetto di non poco conto questo, in quanto si prevede espressamente la possibilità per le Amministrazioni competenti di valutare a monte gli eventuali fabbisogni degli stakeholders, scongiurando così (almeno in linea di principio) possibili scenari “critici” a livello locale in sede di predisposizione dei Piani di raccolta e – quindi – delle relative tariffe.
In quarto luogo, poi, posto che gli articoli relativi alla notifica anticipata dei rifiuti ed al conferimento rimangono nella sostanza quasi immutati rispetto al passato (Cfr. articolo 6 e articolo 7), segnaliamo l’articolo 8 del Decreto, sui “Sistemi di recupero dei costi”. Tale norma prevede, tra le altre, riprendendo interamente quanto previsto dalla Direttiva, l’introduzione di una tariffa indiretta indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti di raccolta (Cfr. articolo 8, comma 2). Tariffa che dovrà essere comunque determinata in sede locale nell’ambito della predisposizione dei citati Piani di raccolta e gestione dei rifiuti mediante un preciso criterio di determinazione; pena un’eccessiva aleatorietà delle tariffe che mal si concilierebbe con i principi unionali di trasparenza e proporzionalità (la norma, infatti, si limita a fissare in almeno il 30% dei costi diretti che devono essere coperti dalla tariffa indiretta).
Last but not least, in tema di esenzioni, l’articolo 9 del Decreto – riprendendo interamente quanto contenuto nella Direttiva sull’argomento – dispone che sia necessario il rispetto delle seguenti condizioni: (i) che la nave svolga servizio di linea; (ii) che esista un accordo che garantisca il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave (comprovato da un contratto firmato con un porto o un’impresa di gestione dei rifiuti, che è stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave e che è stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento); (iii) che l’esenzione non incida negativamente sulla sicurezza marittima.
[hidepost]
*
Individuate, dunque, le principali novità introdotte dal Decreto – a quasi un anno dall’entrata in vigore della nuova normativa – è tempo di tirare le prime somme.
Se la norma, da un lato, ha senz’altro avuto il pregio di tentare di recepire quanto ci è stato chiesto in sede unionale nel rispetto, ad esempio, dei principi di apertura del mercato – sul presupposto che la selezione dell’operatore del servizio è rimessa al soggetto che ne usufruirà ed a carico del quale sono quindi posti i relativi costi in un ambito concorrenziale – così come mira a conseguire un elevato livello di sicurezza e protezione dell’ambiente, dall’altro lato, continuano a permanere alcuni dubbi interpretativi e zone d’ombra che necessitano di chiarimento per l’utenza dei nostri porti.
Primo tra tutti, v’è un tema di tariffa indiretta che – in sede di aggiornamento e/o predisposizione dei Piani di raccolta rifiuti – non dovrebbe essere prevista a carico delle navi di linea (eventualmente) esentate ai sensi del citato articolo 9 del Decreto in quanto non partecipano, per tutta la durata del contratto di conferimento in altro porto lungo la rotta, al mantenimento dell’impianto del porto (esentato). Va da sé che ciò non preclude alle navi esentate il diritto al conferimento, che deve essere limitato a circostanze eccezionali, né le esime dalle ispezioni da parte della competente Autorità Marittima.
Sotto altro e non secondario profilo, v’è poi il tema della (nuova) ripartizione delle competenze tra AdSP e Autorità Marittime con riferimento alla cd. “Autorità competente” al rilascio del certificato di esenzione per le navi di linea che, rispetto al passato, la norma attribuisce in via principale alle AdSP e non più in via esclusiva alle Autorità Marittime; certificati che, tuttavia, non vengono talvolta rilasciati dalle prime e di conseguenza non consentono alle seconde di concedere l’esenzione per le predette tipologie di navi. Sul punto, a cui si aggiunge l’obbligo di stipula di un contratto con uno degli erogatori del servizio di raccolta rifiuti attivo in uno dei porti scalati da notificare successivamente alle Autorità competenti dei singoli approdi interessati ai fini dell’esenzione (obbligo talvolta non facilmente rispettabile in sede locale), v’è l’auspicio di una nota di chiarimento da parte delle competenti Amministrazioni centrali al fine di scongiurare la possibile perdita dello status di navi di linea a servizi di collegamento marittimo che, storicamente, sono sempre stati definiti come tali e hanno usufruito di tale esenzione, comportando quindi un notevole aggravio economico ad esclusivo carico delle predette imprese.
Da ultimo, stiamo assistendo in numerosi porti sede di AdSP ad una progressiva revisione dei vigenti Piani di raccolta ai fini di un necessario allineamento rispetto ai nuovi dettami di legge nazionali ed unionali. Sul punto, sarebbero opportune linee guida comuni da adottarsi a livello centrale che indirizzino l’operato delle Amministrazioni competenti a livello locale nelle interlocuzioni con gli stakeholders nei termini previsti dalla legge.
In conclusione, posto che torneremo sull’argomento con specifici focus di approfondimento sulle tematiche sopra descritte, si ribadisce come il Decreto abbia senz’altro avuto il pregio, seppur in linea di principio, di recepire i dettami europei cercando di allinearli al contesto italiano. Ciononostante, come sopra evidenziato, continuano a permanere degli specifici profili di criticità che se non adeguatamente trattati – anche mediante il ricorso a circolari interpretative da parte delle Amministrazioni centrali, nonché ad eventuali modifiche normative del caso, unitamente ad un adeguato e continuo livello di consultazione degli stakeholders nei contesti portuali locali di Sistema – rischiano, ancora una volta, di incidere in negativo sull’efficienza dei servizi resi alla nave e quindi sulla competitività dei nostri porti.
[/hidepost]