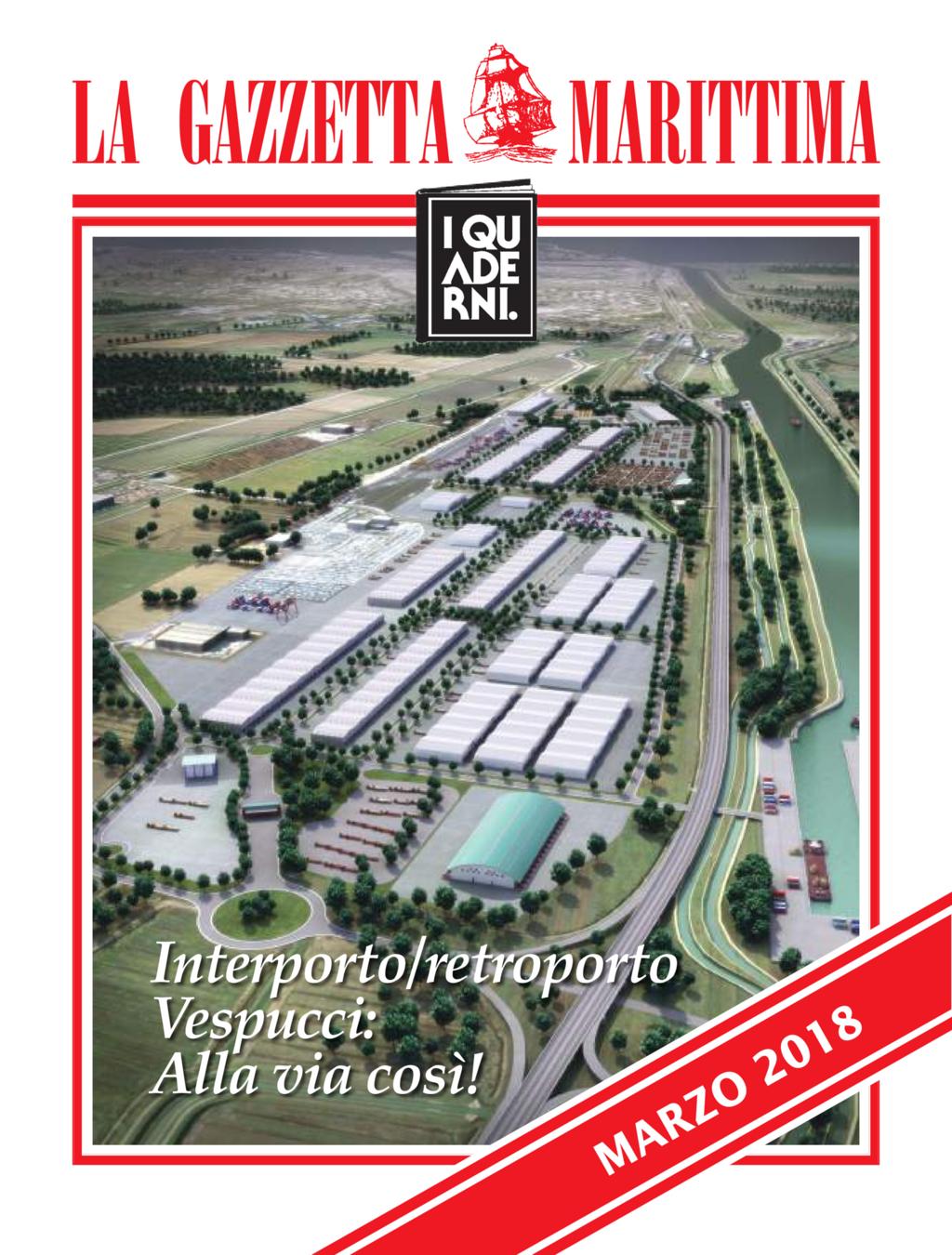Luciano De Majo, sono 15 anni che a tutti noi manca la sua intelligenza appassionata

Il giornalista livornese Luciano De Majo
Sono 15 anni esatti che ci manca la parola di Luciano De Majo, cronista livornese capace di attraversare varie testate di carta (Il Tirreno, La Nazione, L’Unità), vari tipologie di media (non solo la carta stampata ma anche online come Greenreport e radio come Radio Flash) e vari settori (dalla politica allo sport, dalla giudiziaria alla nera, dal sindacato al costume). Se n’è andato troppo presto e ogni tanto viene da chiedersi cosa mai avrebbe detto di fronte alla guerra lui pacifista, di fronte a Trump lui uomo di sinistra, di fronte alla marea montante della diseguaglianza lui così attento all’equità e ai diritti.
Anche quest’anno – l’abbiamo fatto nei lunghi anni al “Tirreno”, lo proponiamo ora in questa nuova avventura alla “Gazzetta Marittima” – pubblichiamo una selezione di articoli che Luciano ha scritto nel corso degli anni E’ una tradizione che ci accompagna così come il tandem di persone e di cronisti aveva accompagnato me e Luciano in precedenza. Stavolta, per una testata economica come la “Gazzetta Marittima”, il focus l’abbiamo dedicato alla persona fra imprenditori e lavoratori, fra diritti e doveri, fra ragioni del cuore e matematica dei bilanci. (mz)

Luciano De Majo, giornalista livornese, scomparso nel 2011 all’età di 40 anni
L’amministratore delegato della Speranza spa
Il Tirreno, 23 novembre 2009
Per piglio e determinazione è un amministratore delegato. Di un’impresa tutta particolare. E forse proprio per questo più vera. Elena Melani, pistoiese doc, 33 anni, è in realtà l’amministratore delegato della speranza. Due lauree, in lettere e in psicologia, e una vita che non si può raccontare se non la si vive. Perché lei ha lasciato al di qua del Mediterraneo, nel cuore della Toscana, il suo passato e il suo stile da occidentale per abbracciare un altro grande cuore: quello dell’Africa.
Il cuore in Africa. Non lascia niente alla retorica, Elena. E davanti alla domanda sul «chi te l’ha fatto fare», si limita a rispondere: «Se non vai in Africa, puoi anche pensare di aver visto tutto, ma in realtà ti manca qualcosa». L’Africa di Elena Melani non è quella degli strateghi dell’alta finanza. Un mese e mezzo vissuto in Madagascar, poi il ritorno in Italia e una telefonata dal Benin. Ora la sua casa è lì, fra i piccoli che insieme alle suore salesiane cerca di strappare alla tratta.
Il progetto salesiano. Laggiù, in quella sorta di “fungo” di terra stretto fra Togo, Nigeria e Burkina Faso, uno dei pochi paesi di quell’area dove comunque ci sono libere elezioni e la democrazia è ormai un fatto compiuto, la battaglia per fermare l’esportazione di bambini passa per la speranza di una loro emancipazione prima di tutto economica. E il progetto di cui le suore salesiane sono protagoniste mette al centro la lotta allo sfruttamento dei minori. «In Benin un bambino costa dai 15 ai 20 euro», dice Elena, che ha trovato in suor Maria Antonietta Marchese, responsabile del progetto, una presenza vulcanica più che dinamica. «Anto, come la chiamo io, è una persona straordinaria», aggiunge la giovane pistoiese. Ma lei non è da meno, visto che si dedica ai più piccoli praticamente 24 ore al giorno, fra attività scolastiche, lavorative e di assistenza di vario genere.
Vidomegon. E’ difficile comprendere, con gli occhi e con il modo di ragionare di un occidentale, quello che succede in Benin. Eppure basta girare per le strade di Cotonou, la capitale economica del paese (oltre 800mila abitanti, di gran lunga la città più popolosa), per imbattersi in una realtà che per la popolazione locale non ha niente di straordinario. Eppure ci sono, secondo statistiche come al solito assai prudenti e quasi ottimistiche, circa 500mila ragazzi dai 6 ai 14 anni che lavorano senza interruzione, senza diritti, senza la possibilità di conoscere l’infanzia. «Una volta in Benin esisteva una pratica – racconta Elena Melani – chiamata “vidomegon”, che significa bambino in lingua fon. Secondo questa tradizione, era possibile affidare i piccoli a famiglie che vivevano in condizioni migliori di quelle nella quale erano nati. In cambio, i genitori avrebbero ottenuto per i propri figli un’educazione altrimenti impossibile».
Regna il traffico. Oggi il “vidomegon” è diventato un’altra cosa. Le spinte solidali si sono trasformate in situazioni assai differenti e in Benin c’è la corsa ad accaparrarsi bambini e bambine. «Soprattutto le ragazzine sono ambite -prosegue il racconto di Elena -perché sono particolarmente docili e sono in grado di fare lavori domestici, ma anche le venditrici». I maschi, invece, trovano facile collocazione facendo lavori di fatica in veste di apprendisti, portando sacchi di cemento nei cantieri aperti in diversi centri del paese. C’è bisogno di tutto, per i piccoli del Benin. Elena Melani, nelle settimane scorse, è tornata per qualche giorno in Italia per motivi di studio e ha fatto visita anche in Toscana, dove ha cercato anche contatti con associazioni di volontariato e enti benefici locali (a Livorno ha incontrato i rappresentanti del Rotary, dell’Arci, del Centro mondialità e la stessa cosa ha fatto in altre città).
Prodotti doc. I bambini del Benin non chiedono soltanto aiuto. Offrono anche qualcosa: i frutti del loro lavoro, delle complesse attività del progetto cui collabora anche Elena. Producono saponi che possono essere commercializzati e che cercano sbocchi sui nostri mercati: l’obiettivo è sondare il terreno con il mondo della cooperazione di consumo. Stanno mettendo su, in Benin, ristoranti e attività alberghiere che potranno diventare davvero, in futuro, un lavoro reale e non solo un modo per sopravvivere fra un espediente e l’altro. A Porto-Novo, la capitale, dove vivono poco meno di 250mila persone, c’è il progetto dell’apertura di una fattoria.
Guerra alla tratta. L’attività delle salesiane fa lo slalom fra una tragedia quotidiana e un’altra. Curano decine di bambine ogni mese sotto il profilo dell’assistenza sanitaria e combattono la guerra più difficile, quella contro il traffico internazionale di bambini. Perché se la degenerazione del “vidomegon” è ormai entrata nell’uso comune del Benin, solo quando i piccoli varcano le frontiere nazionali c’è un po’ di rumore in più. «Ci sono bimbi che vengono portati in Gabon, altri sono destinati alla Nigeria, alla Costa d’Avorio. E a volte – dice Elena Melani – anche il Benin accoglie bambini stranieri, dal Togo e dalla Nigeria». Basta un compenso di una ventina di euro per strappare un figlio ai genitori. E le conseguenze, sul piccolo, sono facilmente immaginabili: maltrattamenti, violenze psicologiche e fisiche. Strapparne anche uno a questo traffico è un’impresa difficile, capace di regalare una soddisfazione straordinaria.
…
«Questa non è vita: ci si sente soli e inutili»
Il Tirreno, 11 settembre 2009
«Ce ne sono tanti che sono in situazioni peggiori della mia. Però una cosa la sento sulla mia pelle: ogni anno, quando viene il 30 giugno, c’è da ricominciare da capo, c’è da battersi per riconquistare un incarico. Alla fine ti senti inutile, nonostante il lavoro che hai fatto per tutto l’anno». Nicola Polizzi, 34 anni, ha abbandonato, almeno per il momento, l’insegnamento specifico delle sue materie – fisica e matematica – e ha preso, anche quest’anno, un incarico a tempo pieno come insegnante di sostegno al “Niccolini Palli”. Precario, come precari sono tutti quelli che insieme a lui hanno pacificamente invaso l’Ufficio scolastico provinciale, Polizzi è ormai al quarto anno di insegnamento. Ha deciso di andare anche lui alla manifestazione di protesta, nonostante non sia fra quelli che rischiano di rimanere fuori: dall’inizio di settembre è formalmente sotto contratto. «Che c’entra, sarei venuto anche se fossi stato di ruolo – dice – e in effetti, se c’è qualcosa che proprio non mi torna è la scarsa solidarietà che mi sembra di vedere, nel mondo della scuola. Mi sarebbe piaciuto se i colleghi di ruolo fossero stati qui, a testimoniare la loro vicinanza. Invece alla fine dei giochi il precario è solo. E questo è un altro elemento di amarezza».
Fuori dall’edificio di piazza Vigo, terminata la manifestazione e l’incontro con la dirigente, alcune giovani precarie discutono della loro situazione. E il punto, da loro sollevato, riguarda il fenomeno delle cosiddette “code”, ovvero la possibilità per i precari di indicare ben quattro province oltre alla propria, come possibili destinazioni. Ne consegue che molti insegnanti provenienti da altre regioni, soprattutto quelle meridionali, con punteggi assai elevati, hanno ottime probabilità di ottenere posti anche da noi. «Più che probabilità, questo è già avvenuto con l’assegnazione degli incarichi – dice Lucia Paradiso, 33 anni – nella nostra provincia. E sia chiaro che non ne faccio un problema di nascita: sono di origine salernitana e non ho niente contro il sud. Ma consentire una gamma di scelta così ampia, ben quattro province, significa mettere a rischio la tenuta della nostra scuola». Lei, Lucia, non è sposata, non ha figli. Non ha ancora, insomma, una famiglia tutta sua. «E difficilmente l’avrò – è il suo sfogo – visto che ancora a 33 anni sono a cercare un incarico di lavoro annuale. Se c’è qualcosa che non mi va giù, è vedere vanificati tutti i sacrifici che ho fatto. Due lauree e ancora nessuna prospettiva concreta di stabilità».
Ha insegnato per quattro anni alle elementari. Italiano, inglese, matematica: quello che c’era da fare, come si fa coi bambini dai 6 ai 10 anni. «E adesso sono senza incarico: mi auguro di ottenerne uno con la distribuzione dei residui – dice – e come minimo dovrò andare all’isola d’Elba, a Portoferraio. Altri sacrifici, ma è sempre meglio che non lavorare». Nel mirino di Lucia Paradiso non ci sono solo le “code”. La critica più forte che rivolge è alla gestione del sistema scolastico. «Questo governo le cose le ha peggiorate – spiega – soprattutto alle elementari, dove senza le ore di compresenza la situazione è più intricata che mai. Prima, in mezzo a tante difficoltà, onestamente si intravedeva un tentativo di gestione differente. Adesso davvero la nostra scuola è in condizioni di gravi difficoltà. E non solo per i guai che colpiscono noi precari».
…
I 42 giorni che sconvolsero il Cantiere
Il Tirreno, 13 dicembre 2009
Quando rientrarono in fabbrica, dopo 42 giorni di sciopero, lo fecero cantando a squarciagola Bandiera rossa. Non perché la bandiera rossa avesse davvero trionfato, come recita il vecchio inno comunista, ma perché la prova di forza cui avevano dato vita i lavoratori del Cantiere Orlando (all’epoca si chiamava Ansaldo) aveva mostrato una capacità di tenuta incredibile: dei 1175 che avevano scioperato il primo giorno, il 17 marzo del 1956, 1135 avevano resistito nell’astenersi dal lavoro fino al 27 aprile, ultimo giorno di lotta.
Il diario. Esiste un diario, dello sciopero più lungo che la storia della città ricordi. Un diario diventato un libro, “I 42 giorni del Cantiere”, scritto da Mario Pagliai, che di quegli avvenimenti fu diretto protagonista. Assunto dal Cantiere nel 1937 come fuochista del reparto montaggio, vi lavorò fino al 1974. E nel 1981 realizzò il sogno di veder pubblicato il libro che raccontava la lotta di 25 anni prima. Oggi di questo libro, andato ormai esaurito, è stata effettuata una ristampa a cura della Erasmo edizioni, che comprende oltre alla prefazione originale di Nelusco Giachini, una presentazione curata dal presidente dell’Anpi Vittorio Cioni e una riflessione “fuorisacco” sul ruolo del Cantiere in città di Mauro Nocchi, storico dirigente del Pci e dell’Arci.
Lo sciopero. L’anno degli avvenimenti è il 1956. Un anno indimenticabile, per la storia del mondo: l’invasione sovietica in Ungheria, il ventesimo congresso del Pcus con la denuncia delle purghe staliniane da parte di Kruscev, ma anche, in Italia, una sostanziale limitazione delle libertà democratiche sancite dalla Costituzione. A scatenare lo sciopero nella primavera del 1956 è una serie di provvedimenti disciplinari presi dalla direzione del Cantiere Ansaldo, che sospende l’intera Commissione interna (compresi coloro che quel giorno non erano al lavoro) e licenzia un operaio, Paolo Sarti, figlio di Urano Sarti detto Pappa, poeta operaio e direttore del Martello, giornale di fabbrica del Cantiere. Qualche giorno dopo, i licenziati diventeranno due: oltre a Sarti, anche Augusto Baldacci. Colpevoli entrambi, secondo i vertici dello stabilimento, di aver protestato durante un’agitazione indetta per l’eccidio di Barletta: il 14 marzo la polizia aveva sparato su un corteo di lavoratori e disoccupati, uccidendo due braccianti e ferendone sette.
La fortezza rossa. In quegli anni, il Cantiere navale ha oltre 1500 dipendenti ed è la fabbrica simbolo della città. Lo scalo Morosini è stato appena ricostruito dopo le distruzioni della guerra grazie anche a una sottoscrizione popolare, la produzione di grandi navi è ricominciata. Alle elezioni per la Commissione interna del 1955, la Cgil ottiene l’84 per cento fra gli operai. E fra gli impiegati Cisl e Uil devono costituire una lista unica per ottenere il 54 per cento in due.
42 giorni. Nel libro appena ristampato (operazione di valore storico e culturale indiscutibile, non avrebbe guastato una migliore cura nella correzione degli errori di battitura) c’è la cronaca puntuale di ciò che avvenne in quei tumultuosi 42 giorni. C’è il racconto delle cariche della polizia che disperdono i cortei spontanei dei lavoratori e dei loro familiari, c’è il resoconto minuzioso delle iniziative cui quegli operai sanno dare vita per creare un circuito di solidarietà incredibile. Ed è questo l’aspetto davvero straordinario che emerge dalla lettura del diario di Mario Pagliai. Perché se il giudizio politico su quello sciopero, proclamato a tamburo battente con l’obiettivo di far ritirare i due licenziamenti, e sui suoi risultati, non è mai stato così tenero neppure da parte dei rappresentanti delle forze della sinistra (Sarti e Baldacci furono, sì, assunti, ma da un’impresa privata e non dal Cantiere, e solo grazie all’intervento di monsignor Andrea Pangrazio, all’epoca vescovo coadiutore), non vi sono dubbi sulla capacità mostrata da quei lavoratori e dai loro gruppi dirigenti di coinvolgere in quella lotta tutta la città e gran parte dei lavoratori della Toscana.
Lascia o raddoppia? Ogni giorno si registrano assemblee di quartiere e riunioni di “caseggiato” alle quali partecipano delegati dalla Commissione interna del Cantiere. Il giovedì sera, poi, le assemblee per sensibilizzare la popolazione diventano ancora più numerose: gli operai vanno a presiederle nei bar, nei circoli, negli spazi comuni dove la gente si riunisce per assistere allo spettacolo televisivo “Lascia o raddoppia?” condotto da Mike Bongiorno. Durante l’arco dello sciopero, una sottoscrizione popolare frutta una raccolta di circa 8 milioni di lire, che vengono distribuiti alle famiglie degli scioperanti insieme a 180 quintali di derrate alimentari anch’esse donate dai livornesi e non solo. Tantissime sono, infatti, anche le iniziative che vengono svolte fuori città. I lavoratori del Cantiere vanno a parlare della loro lotta a Siena, Poggibonsi, Arezzo, Cortona, Montevarchi, Grosseto, Ribolla, Pisa, Pontedera e in tantissimi altri centri toscani. Si spingono fino nel napoletano, al Cantiere navale di Castellammare di Stabia e all’Ilva di Bagnoli.
Da Togliatti. Una delegazione di operai motociclisti l’11 aprile 1956 arriva a Roma dopo una serie di soste per ricevere solidarietà e carburante lungo il tragitto. Il giorno seguente l’incontro con il sottosegretario al lavoro Delle Fave e quello con il segretario del Pci Palmiro Togliatti, il quale dice ai lavoratori che potranno vincere la loro battaglia solo rimanendo uniti, avendo piena consapevolezza della loro lotta e col sostegno dell’opinione pubblica. Vittoria piena, per la verità, come detto, non c’è stata. Ma la nuova edizione del libro sullo sciopero, la presenza in quelle pagine di decine di nomi di operai, impiegati e sindacalisti che condussero quello scontro così aspro per quasi due mesi, sostenendo un braccio di ferro oggi impensabile, è un fatto di assoluto rilievo per la salvaguardia della memoria degli avvenimenti che hanno caratterizzato la città dal dopoguerra a oggi.
…
Amianto, è qui la strage silenziosa
Il Tirreno, 23 settembre 2007
Negli ultimi diciott’anni, sono morti 646 lavoratori dipendenti di aziende che hanno sede in Toscana per il mesotelioma causato dall’esposizione all’amianto. Di questi, 193 vivevano nella nostra provincia. Una percentuale del 25,2 per cento che sale al 31 se consideriamo che 25 lavoratori non erano toscani: sui 621 morti toscani, insomma, poco meno di un terzo erano livornesi. Per la gran parte operai e tecnici del Cantiere navale e ferrovieri.
Il Centro toscano per lo studio e la prevenzione oncologica pubblicherà nell’arco di un paio di mesi queste cifre, che ieri sono state anticipate durante il convegno «Lavoro da morire», promosso da Magistratura democratica e svoltosi alla Cgil.
Stefano Silvestri, che lavora in questo stesso centro e che ieri mattina è intervenuto nel confronto, ha squadernato dati che non ammettono repliche: siamo noi la capitale toscana dell’esposizione all’amianto. Firenze e Prato, le province che seguono quella livornese in questa triste classifica, superano a malapena il 10 per cento dei casi.
L’amianto è un materiale usato a piene mani per tanti anni. Un killer che non lascia scampo e che, da noi, ha colpito soprattutto i dipendenti del vecchio Cantiere Orlando e i ferrovieri. Questi ultimi fanno registrare, sempre secondo le ricerche del Centro per la prevenzione oncologica, un tempo di sopravvivenza più elevato, a dimostrazione che nella cantieristica l’esposizione all’amianto era maggiormente costante e continua. Da segnalare anche che fra i morti per amianto nella cantieristica, sono inseriti anche tre familiari: si tratta delle mogli degli operai che, lavando a casa le tute da lavoro dei coniugi, hanno subito anch’esse l’aggressione della fibra assassina.
Lunghi, lunghissimi, sono anche i cosiddetti tempi di latenza: i tumori affiorano a decine di anni di distanza. Quando cioè molti dei dirigenti e dei responsabili delle imprese sono addirittura morti. «Circostanze che ci fanno affermare – ha detto Silvestri – che siamo davanti a una serie infinita di mesoteliomi impuniti».
…
Morti da amianto, arrivano 5 cause
Il Tirreno, 20 agosto 2010
Il tempo di far passare i giorni tradizionalmente dedicati alle vacanze, poi i ricorsi saranno inoltrati ufficialmente al giudice del lavoro. Saranno cinque. Cinque ricorsi fotocopia, nei quali i familiari di altrettanti lavoratori del Cantiere Orlando chiederanno il risarcimento per l’esposizione all’amianto. Un cammino che si annuncia lungo e faticoso, ma che potrebbe portare a un risultato storico, cioè l’apertura di uno squarcio di luce – sia pure sul fronte della giustizia civile – sull’utilizzo dell’amianto in Cantiere e sulle conseguenze che ha avuto sulla salute dei dipendenti.
A seguire queste cause sarà il giovane avvocato Giacomo Pasquinucci, che proprio in questi giorni ha ricevuto la procura dalle famiglie di Gilberto Sargenti, di Nedo Lippi, di Ivano Pellegrini, di Carlo Tramonti e di Franco Calò. Tutti morti per il mesotelioma pleurico, il pericolo numero uno per chi ha lavorato nel vecchio Cantiere Orlando, dove l’amianto veniva utilizzato a piene mani.
Queste cinque cause rappresentano anche il risultato dell’impegno di molti ex lavoratori, che si sono stretti attorno alle famiglie di alcuni compagni di lavoro che hanno visto morire e le hanno accompagnate fino alla stesura dei ricorsi. Ci sono stati incontri nella sede del circolo ricreativo del Cantiere nei quali sono state ripercorse le storie di ognuno. Operai scomparsi fra i 50 e i 55 anni, che hanno lasciato quelle mogli e quei figli che oggi, vincendo anche tutte le resistenze che in questi casi sorgono spontanee quando si guarda all’iter processuale sicuramente lungo, chiedono giustizia per loro, contando anche sulle testimonianze che i colleghi di allora saranno pronti a portare, una volta convocati dal giudice. E anche la ricerca di questi vecchi lavoratori è stata un impegno non irrilevante.
A essere chiamata in causa dalle famiglie dei “cantieristi” deceduti sarà la Fincantieri. In pratica, lo Stato. Perché il Cantiere Orlando, prima della trasformazione in cooperativa a partire dal 1996, era stato uno stabilimento nell’alveo delle partecipazioni statali. E in quegli anni, prima della legge che metteva al bando l’amianto del 1992, la fibra killer è stata una costante nelle lavorazioni del Cantiere. Nell’ottobre di due anni fa una sentenza del giudice del lavoro di Livorno ha riconosciuto un risarcimento di un milione e 200mila euro alla famiglia di Alessio Ielencovich, impiegato dell’Officina navale, morto a 67 anni nel 2005. Nella perizia ordinata dal giudice per quel procedimento, l’esperto scrisse che 37 dipendenti di quella fabbrica avevano contratto il mesotelioma per aver respirato amianto. Una scia di tumori lunghissima, della quale ancora non è possibile vedere la fine, considerata la lunghezza dei tempi di incubazione della malattia.
….
Più di mille le aziende sotto inchiesta
Il Tirreno, 11 febbraio 2010
Sono più di mille le aziende della provincia di Livorno che non pagano i contributi previdenziali e che, omettendo anche di versare la quota trattenuta dagli stipendi dei dipendenti, finiscono sotto inchiesta della magistratura. «Le aziende che incorrono in questo tipo di insolvenza – conferma Annamaria Gasparri, direttrice della sede provinciale dell’Inps – sono poco più del 10 per cento del totale delle imprese con dipendenti attive nella provincia, che sono 10.093».
«L’obiettivo della nostra sede Inps – prosegue la direttrice – è quello di stigmatizzare sul nascere questo tipo di comportamento, che si configura come reato, fin dal primo insoluto totale della singola azienda». L’insoluto totale è la denuncia contributiva mensile presentata dai datori di lavoro senza versamento di alcun contributo: in sostanza, una condizione nella quale l’azienda riconosce il proprio debito previdenziale ma non versa neppure quanto già trattenuto ai dipendenti. Davanti a questa situazione, l’Inps ha deciso di procedere, «in modo da ridurre ulteriormente il fenomeno», precisa la direttrice, che comunque non manca di ripetere che «la stragrande maggioranza delle aziende che intrattengono rapporti con la sede Inps versano regolarmente i contributi, assistite da professionisti qualificati».
Che cos’è, allora, che spinge determinate imprese (non saranno moltissime, ma comunque mille in una provincia come la nostra non sono neppure così poche) a non pagare neppure le trattenute? «Certamente le difficoltà dell’attuale crisi – risponde Annamaria Gasparri – possono far sì che a talune aziende manchino, in determinate circostanze, le risorse finanziarie occorrenti per adempiere all’obbligo contributivo. Ma in in questi casi è tuttavia necessario versare le quote a carico dei lavoratori, così da non incorrere in profili di reato, e, qualora le difficoltà comprovate dovessero protrarsi, ripianare comunque prima possibile il debito contributivo residuo anche attraverso lo strumento della rateizzazione. L’esperienza dimostra che trascurare troppo a lungo gli obblighi contributivi previdenziali può portare un’azienda a non risollevarsi più, gravata da una mole di debiti in cui gli oneri aggiuntivi, sanzioni e interessi previsti dalla vigente normativa, hanno un notevole peso».
Non solo: un’azienda che non è in regola coi contributi previdenziali incontra mille e una difficoltà nella sua attività di tutti i giorni, visto che spesso è richiesta alle imprese (ad esempio quelle che concorrono per avere commesse pubbliche) l’esibizione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva. «Vorrei anche far notare – conclude la direttrice della sede livornese dell’Inps – che il Presidente Inps Antonio Mastrapasqua, durante il congresso dei consulenti del lavoro dello scorso novembre, ha annunciato che l’Istituto, per venire in aiuto alle aziende in crisi di liquidità e in difficoltà nel pagare i contributi, sperimenterà una piattaforma web attraverso cui i consulenti potranno inoltrare le domande di rateizzazione dei debiti per i quali non sia ancora avviato il recupero con l’invio dell’avviso bonario. Questa dilazione fino a sei mesi potrà essere chiesta solo dai consulenti del lavoro, al massimo una volta l’anno».
…
«Bacino in preda al degrado». Il tribunale: sì al sequestro
Il Tirreno, 6 febbraio 2009
E’ stata accolta dal giudice la richiesta di sequestro preventivo del bacino grande di carenaggio, effettuato in via d’urgenza nei giorni scorsi dalla Finanza e dall’Asl. Tutta l’area del bacino, dunque, comprese le due gru di banchina, è stata bloccata dalla magistratura livornese, a seguito del sopralluogo effettuato ormai una decina di giorni fa dalle Fiamme gialle e dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl.
Ma c’è di più: spunta anche un indagato nel procedimento aperto dalla Procura della Repubblica a seguito dell’esposto dei riparatori navali. Si tratta di Renato Mazza, 53 anni, ingegnere, fino a un paio di settimane fa direttore del Cantiere Azimut Benetti, l’azienda che gestisce il bacino, in concessione dall’Autorità portuale. Le contestazioni che vengono mosse all’ex manager di Azimut sarebbero alcune violazioni al decreto applicativo del nuovo Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Dalla decisione del giudice Elsa Iadaresta emerge un quadro inquietante delle condizioni del bacino di carenaggio. Condizioni che non solo metterebbero a rischio la sicurezza di chi opera nel bacino, ma che rappresenterebbero un elemento di grave pregiudizio della struttura. Il tribunale concentra la sua attenzione sulla presenza di fanghi e sostanze oleose sulla platea del bacino, ovvero il fondo, anche a causa dell’ostruzione delle vie di drenaggio, ma anche sul fatto che le scale di accesso sono invase da tavole di legno e di plastica e da fango e con poca illuminazione.
E’ un capitolo molto delicato, quello delle luci, che sarebbero carenti – e in certi casi addirittura inesistenti – in tutti i passaggi che conducono dalle banchine del bacino alla platea. Mancanti anche le manichette antincendio, essenziali per garantire la sicurezza.
Si tratta, sostanzialmente, dei rilievi effettuati durante il sopralluogo e trasmessi alla Procura – e da questa mandati al tribunale per la richiesta di sequestro conservativo – che dipingono, come dicevamo una situazione complessiva che non è azzardato definire disperata, per le condizioni del bacino. Ci sono richiami alla tenuta della barcaporta (vale a dire la barriera che separa il bacino dal mare e che sopporta la pressione dell’acqua), anch’essa fortemente a rischio, come pure alle infiltrazioni di acqua piovana nelle rampe di scale che dalla banchina portano sul fondo del bacino, tali da interessare gli impianti elettrici e i quadri che alimentano la zona dove viene attualmente costruito uno yacht.
L’impressione prevalente che i tecnici dell’Asl e gli uomini della Finanza hanno tratto dalla loro «missione» in bacino è quella di un degrado diffuso. Degrado che riguarda la banchina ricca di avvallamenti e dossi, che non risparmia le vie d’accesso alla platea che presentano problemi alle pareti, fra vetri e calcinacci dispersi sul terreno, che si estende anche alle taccate, i sostegni sui quali poggiano le navi che entrano in bacino, anch’esse preda della corrosione. Diventa perfino di secondaria importanza l’assenza totale di segnaletica di sicurezza, in un contesto così descritto.
Il tribunale ha anche rilevato che la relazione degli investigatori faceva riferimento alla concessione di impianti che non rispettavano la normativa sulla sicurezza sul lavoro alle imprese che stavano lavorando alla riparazione del pontone «Italia» della ditta Neri. E’ tutto un «complesso di cose», avrebbe scritto Paolo Conte, che ha indotto il giudice a mettere uno stop a questa gestione del bacino e ad accogliere la richiesta di sequestro preventivo.
…
La Fabbrica nel cuore della Città
Il Tirreno, 3 febbraio 2011
Di indissolubile c’era il rapporto fra la fabbrica e la città, la gente comune. Anche perché bastava la parola: Cantiere. Improvvisamente si percepiva che non c’era famiglia livornese che non avesse incrociato la sua storia con quella dello stabilimento-simbolo della città.
Dagli Orlando, siciliani garibaldini, che di fatto dettero il via all’industria cittadina col loro sbarco a Livorno, agli anni del fascismo nei quali i sovversivi erano controllati ma pur sempre tollerati in fabbrica, per garantire la presenza di operai qualificati, in grado di costruire navi efficienti, al dopoguerra denso di battaglie per l’occupazione, fino all’esperienza cooperativa durata cinque anni dopo la decisione dello Stato di ritirarsi da Livorno. La storia del Cantiere Orlando è tante storie insieme, è un intrecciarsi di fatti, di luoghi, di persone e di idee.
L’aspetto più suggestivo, quello che ancora oggi è capace di colpire la fantasia e l’immaginazione, si tocca forse nei modelli delle navi realizzate agli inizi del ‘900. C’era di tutto: ferry-boat come il “Villa”, che imbarcava il treno per collegare Sicilia e Calabria, oppure yacht di super-lusso come il “Flying Cloud” costruito per il duca di Westminster, una dimora galleggiante sontuosa per gli anni ’20. Ma attenzione alle produzioni militari, che se da un lato rappresentarono il nerbo dell’attività del Cantiere Orlando all’inizio della sua avventura proprio per dotare il neonato Stato unitario di una flotta adeguata, tornarono in auge nel periodo fra le due guerre. Ne aveva un disperato bisogno l’Italia fascista smaniosa di conquistarsi un posto al sole, eppure nessuno ha mai dimenticato l’epopea del “Tashkent”, incrociatore veloce che il Cantiere realizzò per la Marina militare sovietica. La leggenda narra che gli operai livornesi ci misero l’anima nel costruirlo. E in effetti l’unità arrivò alla velocità di 44 nodi in prova.
Il muro che divideva la fabbrica dalla piazza Mazzini, in realtà, era solo immaginario. Perché dopo le distruzioni belliche, i livornesi promossero addirittura una sottoscrizione perché lo scalo Morosini, lo scivolo gigante su cui prendevano corpo le grandi navi, fosse ricostruito non dopo, ma insieme alle loro case. «Cemento per lo scalo Morosini», scrissero i giornali dell’epoca. E fu festa grande quando, alla fine, la decisione presa fu proprio quella: il “Morosini” rinacque per essere poi abbandonato negli anni ’60, quando la proprietà della fabbrica, ormai ampiamente nelle mani delle partecipazioni statali, ne decise un drastico ridimensionamento della capacità produttiva. L’accordo raggiunto a Roma – era il 1962 – portò alla creazione della Cmf di Guasticce, dove venne dirottata parte della manodopera del Cantiere.
Non è azzardato dire che il resto è storia di oggi, o quasi: la decisione di Fincantieri di disfarsi della fabbrica a metà degli anni ’90, la nascita di una cooperativa che non aveva precedenti nel settore delle produzioni e delle riparazioni navali, la cui avventura è terminata con una grave crisi sulla cui genesi e responsabilità la città non si è mai interrogata in modo approfondito. Oggi, dove una volta sorgeva il Cantiere di San Rocco, campeggia l’insegna di Azimut Benetti. Non più gasiere o traghetti, ma yacht di lusso. I tanti “Flying Cloud” del terzo millennio.
…
«Io, presa di mira e poi licenziata»
Il Tirreno, 28 settembre 2007
Dalla sua ha avuto non uno, ma due pronunciamenti dei giudici. Prima il verdetto del giudice del lavoro, poi il secondo grado. Ora l’azienda che l’ha licenziata e che avrebbe dovuto reintegrarla l’ha inserita nuovamente nel registro dei dipendenti. Solo che la tiene a casa, versandole lo stipendio (il minimo, ovviamente) e senza farla lavorare. Lei, la protagonista di questa storia, si chiama Maria Pia Molinaro. Ha una figlia e un mutuo da pagare. «Ma con questi soldi – dice – sono destinata a perdere la casa dove viviamo». L’azienda, invece, è la Liburnia servizi, conosciutissimo istituto di vigilanza privata.
L’accusa che lancia la donna è gravissima. «Sono perseguitata da un’azienda maschilista – spiega – e tutto questo solo perché ero l’unica donna ad avere funzioni di comando nell’azienda». Il caso di Maria Pia Molinaro, che dal punto di vista sindacale è assistita dalla Cisl, è stato seguito anche dalla consigliera di parità della Provincia Maria Giovanna Lotti, che ha provato a sollecitare la Liburnia servizi a reinserire la donna nel ruolo che prima ricopriva. Perché il punto del contendere sta tutto lì: l’amministratore delegato dell’azienda Carmine Cobuccia respinge al mittente ogni accusa di questo tipo. «Figuriamoci – dice – se abbiamo un problema del genere: la nostra responsabile commerciale è una donna. Nessun maschilismo, e nessun mobbing. La nostra azienda non fa più servizio portavalori, perché non rendeva assolutamente e, alla resa dei conti, più che un introito era un costo. Per questo abbiamo chiesto alla signora di cambiare mansione: lei non ha accettato e siamo arrivati a questo punto: non ci è rimasto che comunicarle il licenziamento».
Ma la signora Molinaro non lesina particolari su come si è sviluppata la vicenda. «Le hanno provate di tutte per farmi arrendere – dice – quando il personale che doveva eseguire le mie indicazioni faceva di testa sua e, deliberatamente, non si comportava come avrebbe dovuto. Poi è arrivata la proposta di demansionamento: che cosa dovevo fare? Accettare di regredire? Ho detto di no e come risposta è arrivato il licenziamento».
Assistita dall’avvocato Francesco Miccoli, Maria Pia Molinaro si è rivolta alla giudice del lavoro Silvia Barison, che ha ordinato all’azienda di reintegrarla. Decisione che è stata ribadita, in secondo grado, anche dai giudici del tribunale ai quali l’azienda aveva fatto appello. A quel punto, la Liburnia avrebbe dovuto far tornare la donna al lavoro. «Ma la sua mansione – ribatte l’amministratore delegato – non esiste più. Ripeto: il servizio portavalori non lo facciamo». Risposta della Cisl, il sindacato che tutela la donna: «Per quale motivo, allora, quando partecipa alle gare pubbliche quest’azienda inserisce, fra le sue credenziali, l’abilitazione a svolgere questo tipo di servizio?». A un certo punto, qualche settimana fa, un punto di intesa era stato quasi individuato, almeno secondo il legale di Maria Pia Molinaro, perché a luglio era andato in pensione il responsabile della centrale operativa della Liburnia. «Quel ruolo sarebbe andato benissimo alla signora Molinaro – dice l’avvocato Miccoli – perché corrispondeva, fra l’altro, al livello al quale era inquadrata». Anche in questo caso, però, l’operazione di reinserimento non è andata a buon fine. L’azienda spiega questa scelta con la necessità di formare in modo adeguato la donna prima di poterla investire di questo compito. «E noi – dice l’amministratore – non possiamo permetterci di avere un responsabile di centrale operativa da formare».
Maria Pia Molinaro, insomma, è ancora a casa. Dice di trovarsi in una situazione difficile dal punto di vista psicologico ancora prima che economico. Non lavora e riscuote un migliaio di euro al mese. «Erano il doppio – racconta – fra indennità di funzione e straordinari. La Liburnia dice di essere disposta a discutere con me? La verità è che per ora non ha mai risposto alle mie sollecitazioni».
…
Inaugurazione a Livorno nel cantiere rilevato dai dipendenti: varata la nave coop
L’Unità, 12 gennaio 1997
Un anno fa la grande scommessa: la decisione di acquistare il Cantiere navale, sottraendolo alla chiusura ormai certa decretata dalla Fincantieri. Ieri questa decisione ha dato il primo risultato. Davanti al vicepresidente del consiglio Walter Veltroni, è stata varata la prima nave costruita dai lavoratori del «Cantiere Navale Fratelli Orlando», il cantiere autogestito. È la «Monte Bello», una cisterna porta prodotti chimici e petroliferi, commissionata al cantiere dalla Società marittima e fluviale di navigazione» di Savona.
Una cerimonia suggestiva, che ha ribadito tutta la particolarità di una fabbrica laboratorio, il primo (e finora unico) esempio di cantiere navale privatizzato dai lavoratori in Europa. Proprio da questa esperienza è partito Veltroni, per esprimere il pieno sostegno del governo all’operazione dei dipendenti: «I lavoratori hanno avuto grande coraggio. Decidendo di rischiare direttamente e di diventare imprenditori hanno evitato alle loro famiglie un futuro di disoccupazione. Questa nave – ha detto prima del varo – è il simbolo di una città che riprende a navigare, che torna a far marciare i meccanismi della propria economia dopo anni di crisi. Un po‘ come il nostro paese, che lentamente riprende a camminare». Un concetto, questo, che Veltroni aveva già espresso qualche ora prima, in occasione della sua visita a palazzo civico: «Diciamo che un anno fa abbiamo trovato un paese a rischio. E se anche non possiamo affermare di aver compiuto per intero la nostra opera, non è azzardato dire che adesso c’è qualche motivo in meno per essere pessimisti, rispetto a qualche tempo fa».
Ma quella di ieri è stata la giornata del cantiere navale di Livorno, di quel cantiere che ha scelto una strada sicuramente difficile, quella dell’autogestione, eppure capace di dare apprezzabili risultati, grazie alla tenacia dei 350 lavoratori che hanno costituito cinque cooperative riunite in un consorzio rilevando la fabbrica più antica di Livorno. Oltre alla «Monte Bello», scesa in mare ieri circondata dall’affetto di tutta la città (il cantiere era gremito di pubblico), nel portafoglio del cantiere livornese ci sono altri undici contratti- nave, a dimostrazione di una «fiducia ormai conquistata dal mercato nazionale e internazionale», come ha detto il presidente del consorzio delle cooperative Massimo Serafini. Con l’ambiziosa prospettiva di spostare la linea di produzione dall’attuale angusto scalo Umbria al vecchio scalo Morosini, per costruire navi più grandi e rinnovare una tradizione cantieristica che dura ormai dal 1866. Quello di ieri, giurano i lavoratori, non è certo l’ultimo varo, anzi l’inizio di una nuova entusiasmante avventura dopo anni di contrasti e scontri con la Fincantieri.
…
I 30 soci della Proletaria ora sono 650mila
L’Unità, 20 febbraio 2005
In principio erano trenta soci fondatori. Operai e impiegati degli stabilimenti siderurgici di Piombino, che dettero vita ad una cooperativa, chiamandola «La Proletaria». Da quel 26 febbraio del 1945 sono passati sessant’anni, che Unicoop Tirreno (questo l’attuale nome della cooperativa che per tutti gli anni ’90 si era chiamata Coop Toscana-Lazio) si appresta a festeggiare con iniziative che arriveranno fino al 2006. Oggi i soci di questa cooperativa sfiorano i 650 mila, distribuiti fra Toscana, Umbria, Lazio e Campania.
Il presidente di Unicoop Tirreno, Aldo Soldi, che guida anche l’associazione delle coop di consumo aderenti alla Lega, rivolge il suo primo pensiero proprio ai pionieri di sessant’anni fa. «Se questi operai e impiegati piombinesi si misero insieme, fu perché c’era da difendersi dalle speculazioni del mercato nero, da ricostruire il paese e la sua economia, per rispondere a un bisogno collettivo. In questa loro scelta c’era la voglia di costruire una società più giusta, non solo una necessità contingente, c’era una voglia di futuro. È un’idea che ci anima ancora oggi».
Una grande cooperativa come Unicoop Tirreno sa ancora declinare la parola cooperazione senza cedere alla tentazione di parlare solo di impresa?
«Se ci pensiamo bene, è questo il segreto del successo. Da una parte, essere un’impresa all’altezza delle altre aziende di distribuzione, anche a livello internazionale, e in molti casi anche meglio di esse. Dall’altra, mantenere le caratteristiche di un’ impresa sociale e radicata nel territorio, che si comporta diversamente da altri soggetti».
Come?
«Faccio un esempio: quando noi pensiamo a un prodotto a marchio Coop, non pensiamo a qualcosa da cui tirar fuori il più alto margine di guadagno. Pensiamo a un prodotto che risponda alle caratteristiche della salubrità, dell’igienicità, dell’eticità della catena, insomma ad un prodotto carico di significati e di responsabilità. Il nostro marchio si porta dietro tutti questi significati. È una coerenza che costa, ma che i consumatori apprezzano».
Le coop hanno denunciato tempo fa l’attacco da parte del governo Berlusconi con la riforma del diritto societario. Come vanno le cose?
«Era un attacco consistente, respinto sia per la mobilitazione del mondo cooperativo e dei suoi alleati sia per posizioni significative che sono state espresse anche da alcune parti della stessa maggioranza. Ne è uscita una disciplina che ha peggiorato la situazione, ma che non è rovinosa come avrebbe potuto essere».
Questo calo delle spese nella famosa quarta settimana del mese la percepite?
«Sì, purtroppo sì. E dico purtroppo non per le nostre vendite, ma per la situazione del paese. Una quota sempre maggiore di famiglie si va impoverendo. Retribuzioni e pensioni non stanno al passo con il costo della vita. Ed i consumi obbligati, tariffe, tasse, affitti, carburanti, hanno aumentato di molto la loro incidenza. Resta una quota di reddito più bassa per il resto dei consumi: per la prima volta nel 2004, abbiamo registrato una diminuzione dei consumi alimentari rispetto all’anno precedente. È un fenomeno che non accadeva da moltissimi anni».
Ora vi chiamate Unicoop Tirreno, nome simile a Unicoop Firenze. Fusioni in vista?
«Ci siamo chiamati Unicoop Tirreno per valorizzare il fatto che la cooperativa stava unificando anche altre esperienze, come Coop Tevere e Coop Unione Ribolla, con la quale la fusione è ormai prossima. Con Unicoop Firenze stanno crescendo le occasioni di collaborazione, andiamo oltre i rapporti di buon vicinato. Ma non stiamo parlando di fusioni a livello così ampio».
…
Porto di Livorno, guai a chi parla
L’Unità, 1 marzo 2005
Liberi di esprimere le proprie opinioni e di raccontare ciò che non va sul loro posto di lavoro, ma fino a un certo punto. È così che l’Autorità portuale di Livorno vorrebbe i suoi dipendenti. Tanto che, nel giorno di un’assemblea di tutti i lavoratori del porto indetta dalla Cgil, il segretario generale dell’authority, commissariata dal governo da ormai più di venti mesi, emana un «avviso al personale», facendolo affiggere prima nell’area dove i dipendenti dell’Ente timbrano il cartellino e poi allegandolo ad ogni busta paga insieme allo stipendio di febbraio.
L’avviso porta la firma del massimo dirigente dell’Autorità portuale di Livorno, Aldo Beccani, nominato segretario generale dal commissario Bruno Lenzi. Contenuto stringato ma chiaro. Si richiama il personale all’osservanza dei contenuti dell’articolo 32 del Contratto di lavoro, con un riferimento «in particolare» al fatto che chi è dipendente dell’Autorità portuale di Livorno «non deve dare ad estranei, o chi non ne ha diritto, informazioni o comunicazioni relative all’organizzazione, metodi e servizi dell’azienda/ente, nonché relative a provvedimenti ed operazioni amministrative anche se non si tratti di atti riservati, dei quali sia venuto a conoscenza a causa del suo servizio». E come ciliegina sulla torta, arriva anche la minaccia finale: «Il mancato rispetto della predetta disposizione contrattuale comporta l’applicazione di sanzione disciplinare».
La rappresentanza della Cgil ha replicato a questa mossa dell’Authority con una lettera che respinge «senso e contesto» dell’avviso. «Contestate qualche lavoratore formalmente, in modo da dargli la possibilità di difendersi -scrive la Cgil – oppure tale avviso è da ritenersi un puro atto di intimidazione di stampo fascista verso i lavoratori che avevano partecipato ad un’assemblea».
….
Passerà alla storia per l’intuizione del container che ha cambiato il porto
Il Tirreno, 20 marzo 2010
Ventisei anni interi passati al comando della Compagnia portuali, i migliori. Gli anni del rilancio, del boom, dell’affermazione più forte. Italo Piccini è stato il leader indiscusso di una famiglia, di un’impresa, di un clan. E’ stato tutto questo e altro ancora. E’ stato un leader economico e politico, un condottiero capace di creare consenso e di gestirlo.
L’uomo della Venezia. Era un uomo del popolo, Italo Piccini. Nato il 4 novembre, anniversario della vittoria della Grande guerra, nel 1927. Vissuto e cresciuto nella Venezia povera e solidale fra le due guerre. Ed è quello il mondo dal quale diceva di aver tratto gli insegnamenti più importanti. E’ quello l’ambiente nel quale sono maturati gli aneddoti della sua giovinezza, che ha raccontato più e più volte durante la sua vita di politico, di organizzatore, di imprenditore.
Allievo di Jacoponi. E’ stato un allievo di Vasco Jacoponi. Ed è a lui che è subentrato, nel 1963, alla guida della Compagnia lavoratori portuali. Dell’azienda di via San Giovanni ha tenuto il timone per un quarto di secolo, fino a quel 1989, grande e terribile, che per la vecchia gloriosa Clp significò l’irruzione traumatica dei decreti Prandini e il commissariamento. Anche dopo quel periodo, però, Italo Piccini ha saputo continuare a rimanere ai vertici della “sua” compagnia che nel frattempo ha conosciuto le trasformazioni alla quale è andata incontro. A lui, al suo intuito, alla sua voglia di misurarsi con le innovazioni che l’evoluzione del lavoro e delle regole sulle banchine imponevano, si deve la nascita della Cilp, la prima vera e propria “cooperativa impresa”, come fu chiamata al momento della sua nascita, dei portuali, che divenne il braccio attraverso il quale la Compagnia partecipava ai vari terminal privati del porto.
Dialogo coi nemici. Piccini in porto ha avuto amici e nemici. Tanti amici, quelli con cui ha lavorato, quelli con i quali ha costruito alleanze, e anche tanti nemici. Eppure chi ha conosciuto da vicino il console sostiene che la sua grandezza è stata proprio quella di non aver mai sancito inimicizie “per sempre”. Italo Piccini si è scontrato, a più riprese, con tanti personaggi, anche molto importanti, senza mai rompere personalmente con gli interlocutori con cui aveva a che fare. Anche nei momenti in cui i conflitti si facevano più intensi – conflitti di carattere economico ma anche politico – la capacità di lasciare uno spiraglio al confronto, al dialogo, all’accordo in extremis era fra le sue doti maggiori. Di lui, e degli altri grandi del porto, si diceva che fossero soliti sancire le intese più importanti con una stretta di mano. Bastava quella per suggellare alleanze in grado di portare lavoro e sviluppo al porto di Livorno.
La politica. Italo Piccini era anche un condottiero politico. Non solo perché seppe dirigere un’azienda tutta particolare come la Compagnia portuali, ma perché la sua attività di uomo d’impresa si è sempre intrecciata con l’appartenenza politica al vecchio Partito comunista e, successivamente, alle forza politiche che sono nate dalle trasformazioni del Pci, per finire con l’attuale Partito democratico. Nelle file del Pci Italo entra in consiglio comunale con le elezioni del 22 novembre 1964. E’ console della Compagnia da un annetto, lui ottiene 1.718 preferenze, superato soltanto dal sindaco Badaloni, dal segretario del partito e i più alti dirigenti, in un’epoca nella quale la battaglia personale per le preferenze era gravemente proibita, all’interno del Pci. Sui banchi del consiglio comunale Italo Piccini rimarrà fino al 1980, ottenendo per due volte la riconferma. Ma non è solo quella la sede nella quale porta avanti le sue battaglie politiche, sempre pronto a discutere prima di tutto nelle stanze del suo partito, scontrandosi talvolta con le posizioni di chi, in qualche modo, teme che la Compagnia possa diventare un potere perfino troppo forte in città.
Container e cultura. Ma sono gli anni nei quali la Clp fa segnare i progressi più vorticosi, gli anni in cui il console mette a frutto i risultati di quella che, probabilmente, è la sua intuizione più importante, quella del container. Grazie a questa, il porto di Livorno diventa fra i più significativi dell’intero bacino del Mediterraneo. Lo dicono le statistiche storiche: se nel 1966, all’inizio della gestione Piccini, i “teus” movimentati dal porto sono 12mila, nel 1979 sono 300mila. E nel 1986, il nostro scalo fa segnare il record nel Mediterraneo, con 580mila teus, entrando nel gotha dei porti, superando di slancio Marsiglia e facendo concorrenza ai giganti del nord di Rotterdam e Amburgo. Appena tre anni dopo, le cose per la Compagnia portuali sarebbero cambiate traumaticamente, con l’approvazione dei decreti Prandini e l’arrivo del commissario. Anche in quell’occasione Italo Piccini e il suo gruppo dirigente non mancano di dare vita a una prova di forza straordinaria, con i portuali che sfilano per le vie della città come un mare interminabile di folla. Ma è comunque un’era che si chiude. L’era della vecchia Compagnia, quella che sulle banchine muoveva merci e lavoratori e che sapeva costruire anche cultura. E’ del 1967, infatti, l’apertura della biblioteca dei portuali. Al palazzo di via San Giovanni, l’inaugurazione avviene alla presenza del senatore Franco Antonicelli, al quale poi i portuali intitoleranno una fondazione. La biblioteca diviene un punto di riferimento per i giovani di tutta la città. Un luogo di aggregazione oltre che di consultazione, la vera biblioteca nella quale i ragazzi di Livorno vanno a studiare e a trascorrere i loro pomeriggi.
Da un Piccini all’altro. Nel 1989 dei decreti Prandini Italo Piccini si fa da parte e lascia la poltrona di grande timoniere della Compagnia, ma il suo consenso fra i lavoratori resta sempre alto, tanto da guadagnarsi sempre la conferma nel consiglio d’amministrazione. Al suo posto, alla guida della Clp, poi diventata Cpl, si insedia suo figlio Roberto, con il quale il confronto delle idee sarà sempre vivo e reale, mai scontato. Fino all’ultima grande scelta, quella sul socio per la Darsena Toscana, il più grande terminal del nostro porto. Roberto Piccini sosteneva gli spagnoli di Dragados, Italo puntava sul gruppo Contship. E’ lui a vincere la contesa, alla maniera solita dei portuali. Assemblee affollatissime nella “mitica” sala Montecitorio del palazzo del portuale, confronti, scontri. Poi la decisione. E la stretta di mano finale che chiude la porta a ogni strascico polemico: c’è da guardare avanti, la Compagnia portuale prima di tutto. Italo lo sta pensando anche adesso.
…
«Conti choc, poi detti le dimissioni»
Il Tirreno, 10 ottobre 2009
C’erano due versioni della relazione del collegio sindacale al bilancio del Basket Livorno al 30 giugno 2008. Una è quella depositata insieme al bilancio, della quale abbiamo dato conto due giorni fa, nella quale i revisori sospendevano il giudizio sul bilancio stesso subordinandolo al rispetto degli impegni presi da «autorevoli esponenti dell’amministrazione comunale». Una, invece, è quella che il presidente del collegio, il ragionier Enrico Costagli, consegnò all’assemblea dei soci, ma che è misteriosamente scomparsa dalla scena, probabilmente sgradita ai soci.
«Sia chiaro – precisa adesso Costagli – che io la relazione di cui voi avete scritto non la conosco proprio, è la prima volta che la vedo. Il documento che io sottoposi all’assemblea è un altro. Lo firmai io soltanto, e non gli altri due membri del collegio. Poi accadde che l’assemblea venne interrotta e riprese quattro giorni dopo. Io a quel punto mi dimisi e non andai alla prosecuzione dell’assemblea. Quindi la relazione che poi è stata prodotta non mi appartiene assolutamente».
Ricostruendo i fatti, dunque, stando a quanto afferma Costagli il pomeriggio dell’11 dicembre all’attenzione dell’assemblea arriva una relazione. Una relazione differente, nella forma e nella sostanza, da quella che poi sarà allegata al bilancio. Anche perché il verbale di assemblea, nel riferire quanto accaduto nella prosecuzione della riunione, dice chiaramente che Costagli è assente e che risultano presenti i soli sindaci Cristiana Salvi e Massimo Innocenti. Costagli, che aveva rassegnato le sue dimissioni evidenziando quindi una spaccatura di non lieve entità nell’organo di controllo della società, non vi ha partecipato.
Dal confronto fra la prima versione della relazione – quella presentata dal presidente del collegio – e quella che invece poi è stata approvata, emergono alcune differenze sostanziali. La prima sta nella conclusione: Costagli invitava l’assemblea «a valutare attentamente il bilancio presentato e a deliberare senza indugio gli opportuni provvedimenti per la copertura della perdita d’esercizio», chiamando i soci a sborsare il denaro per ripianare il deficit maturato. Nella relazione poi allegata, i revisori dicono invece di essere «stati informati che la copertura della perdita avverrà mediante rinuncia da parte dei soci ai finanziamenti postergati iscritti in bilancio e ad ulteriori versati nei primi mesi del corrente esercizio».
Poi c’è la questione dei rapporti con l’amministrazione comunale. Costagli non ne fa menzione. La sua conclusione è che non è possibile «formulare un giudizio se il bilancio nel suo complesso sia stato redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società». La relazione “ufficiale” mantiene la sospensione del giudizio, ma introduce nelle sue considerazioni il punto degli accordi e degli impegni presi dal Comune. A un certo punto, infatti, i revisori scrivono che gli amministratori del Basket Livorno asseriscono che «la continuità aziendale è assicurata dall’impegno dell’amministrazione comunale» e aggiungono che «tale indicazione ci è stata confermata da autorevoli esponenti della stessa amministrazione».
Tutti particolari che mancano dalla prima versione, come conferma lo stesso Costagli. «Di impegni presi dall’amministrazione non sapevo assolutamente niente – dice – se non di buone intenzioni espresse durante i consigli d’amministrazione, per cercare di reperire contatti con eventuali sponsor. D’altra parte, credo che il Comune avesse fatto già molto per mantenere in piedi l’attività della pallacanestro a Livorno. In quel caso, ciò che mancava era una reale strategia da parte dei soci privati, che avevano la maggioranza delle quote. La Livorno sport, espressione del Comune, aveva il 5 per cento, gli altri tutti insieme erano proprietari al 95 per cento, questo è bene non dimenticarlo».
…
Ecco i metalmeccanici, le ragioni della lotta «Questione di lealtà e dignità»
L’Unità, 27 settembre 1996
«In fabbrica sono entrato quando non ero più giovanissimo. Era il ’74. Ora ho cinquantatré anni e ho vissuto tutte le ristrutturazioni». Roberto Panciatici si definisce un «superstite» della Motofides, lo stabilimento livornese passato di recente sotto il controllo della Marelli. Non ci mette molto a spiegare il perché dello sciopero di oggi: «È innanzitutto un problema di lealtà e dignità delle parti. Lealtà, sì, perché siamo di fronte a una controparte che non intende rispettare gli accordi assunti. E dignità, quella a cui noi lavoratori abbiamo diritto. È inammissibile sentirsi rispondere così, che i nostri interlocutori, all’improvviso, dimentichino ciò che hanno firmato nel ‘93».
Da quell’accordo sono passati tre anni. Eppure il ricordo dei giorni nei quali venne raggiunta l’intesa sul costo del lavoro è ancora vivo, nel delegato della Marelli: «Il solo fatto che l’accordo del ‘93 produsse così tante divisioni nel mondo del lavoro dovrebbe indurre la Federmeccanica a rispettare i propri impegni. Ora, invece, sembra che quelli di questi giorni siano gli effetti dell’accordo. No, diciamolo una volta per tutte: – afferma Panciatici – se siamo giunti a questo punto, è perché l’accordo non viene rispettato, si viene meno a un’intesa siglata, non si tiene fede ai patti».
Ma la gente comune, quella che non ha nel proprio vocabolario le «dinamiche salariali », come può capire lo sciopero dei metalmeccanici? «Credo che questo paese abbia bisogno di crescere e di ritrovare serenità in ogni suo settore. Le nostre richieste non sono incredibili come qualcuno vorrebbe farle sembrare. Non è vero, come dicono i signori di Confindustria, che in questo modo si va verso il fallimento delle industrie. Ecco perché scioperiamo: perché vogliamo difendere il nostro diritto a lavorare nella dignità».
La mente corre agli anni passati, agli anni ‘80 che Panciatici identifica come un «passaggio drammatico», ai tempi in cui le famiglie vivevano con l’incubo costante della cassa integrazione: «Io ho vissuto tutte le ristrutturazioni tipiche di un’azienda che ha risentito fortemente delle dinamiche interne al gruppo Fiat e fortunatamente ho sempre evitato la cassa integrazione. Tornare alla situazione di quei tempi sarebbe davvero drammatico: significherebbe far ripiombare le famiglie nel terrore e i lavoratori in una condizione brutta, bruttissima. C’è chi è arrivato al suicidio, perché una volta fuori dal ciclo produttivo si sentiva ormai inutile, quasi fuori dal mondo. Credo che sia giusto riflettere, tutti insieme, sul valore di questo sciopero».
Luciano De Majo