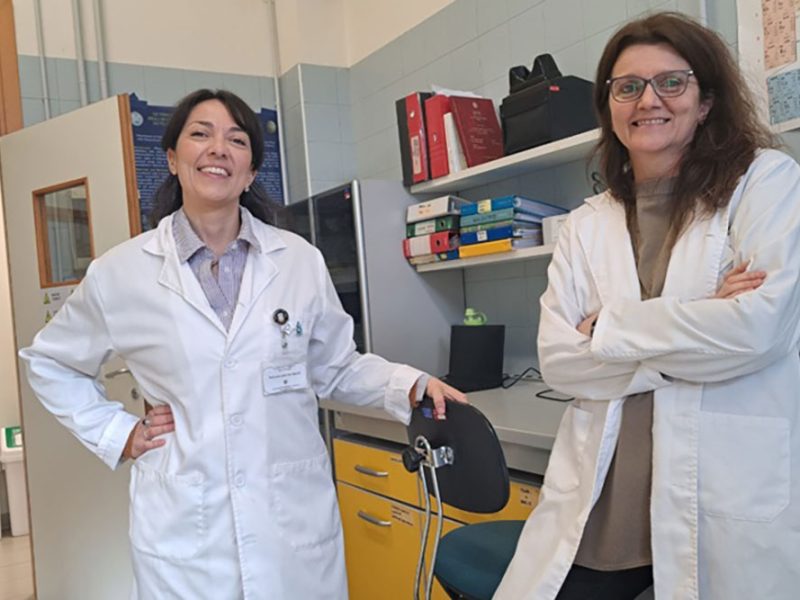Impianti per le rinnovabili, la Regione indica le zone dove accelerare la localizzazione
Attenzione all’autogol: l’interporto di Guasticce rischia di veder azzoppato lo sviluppo
 FIRENZE. Le hanno chiamate “zone di accelerazione”: si tratta delle aree in cui può avere una marcia in più la realizzazione di impianti fotovoltaici e di impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti. Nella fattispecie, stiamo parlando di:
FIRENZE. Le hanno chiamate “zone di accelerazione”: si tratta delle aree in cui può avere una marcia in più la realizzazione di impianti fotovoltaici e di impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, incluse le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio di tali impianti. Nella fattispecie, stiamo parlando di:
- le aree a destinazione industriale,
- le coperture degli edifici,
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte,
- le aree all’interno dei porti e degli interporti,
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane,
- i siti delle società di gestione aeroportuale,
- i parcheggi nei quali si intende installare moduli fotovoltaici posizionati su pensiline o tettoie,
- le discariche chiuse anche se ripristinate.
Vengono indicate nel “Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili” che l’assessora regionale Monia Monni, titolare della delega alla transizione ecologica, ha presentato nell’assemblea consiliare della Regione Toscana. Ben venga la creazione di strutture per produrre energia rinnovabile ma al tempo stesso non può avvenire a vanvera per non generare più problemi di quanti ne risolva. «Non può esserci un progresso vero – afferma Monni – se il cammino verso il nuovo modello energetico non è anche giusto, partecipato e rispettoso delle specificità di ogni territorio e quindi, la diffusione delle fonti rinnovabili diventa la colonna portante di un processo di conversione, però deve essere ben pianificata e gestita per non creare nuove criticità ambientali, sociali e territoriali». Ad esempio, per far capire il senso del provvedimento, Monni spiega che restano al di fuori delle “zone di accelerazione” «le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale».
Il piano non mette sul tavolo soldi: non si attivano risorse finanziarie, «né regionali né di altra provenienza», – viene chiarito – quel che viene messo in campo è un cronoprogramma (da «riesaminare periodicamente ed eventualmente modificato») che tenga conto del «monitoraggio sugli obiettivi di conversione energetica».
Lo ribadisce l’assessora: è certo che questo genere di impianto risultino «un presupposto strategico per lo sviluppo della nostra regione», e tuttavia – tiene a puntualizzare – «la loro diffusione va armonizzata, eliminando gli elementi di conflitto con gli altri usi del suolo, agricoltura, paesaggio, biodiversità». Di più: «Individuiamo come zone di accelerazione quelle che la legge regionale avrebbe individuato come zone a idoneità assoluta, dove potenzialmente il conflitto è molto più basso, le industriali, i porti, i tetti».
C’è da considerare, ad esempio, che la normativa nazionale, pur di incentivare la diffusione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, consente alle pratiche di saltare tutta una serie di passaggi autorizzativi e, in sostanza, avoca a sé a livello ministeriale centrale il cuore dell’iter, anche a costo di tagliar fuori le istituzioni locali dalla gestione del loro territorio.

L’interporto Vespucci di Guasticce (LI)
È comunque una questione che non riguarda solo la possibilità di destinare agli impianti di energie rinnovabili potenzialmente una buona parte del territorio, in particolare quello in cui il paesaggio è contrassegnato già da realtà di tipo industriale, compresi porti e interporti. Ma proprio l’interporto di Guasticce (Livorno) offrirà un caso specifico in cui forse gli “ingranaggi” burocratico-amministrativi di semplificazioni estensive rischiano di avere l’effetto di un autogol: basti pensare all’effetto che avrebbe, anche solo involontariamente, uno stop all’espansione dell’interporto livornese ormai saturo (praticamente sono rimasti disponibili solo ritagli). Una espansione in direzione est: verso l’entroterra della più vasta piana alle spalle del porto tirrenico più vicino ai mercati di destinazione. La piana valdarnese fin oltre Pontedera, perfino con spazi lato nord verso l’estrema periferia di Pisa, ha dalla sua il fatto di essere geograficamente accanto a un porto fra i primi 25 del Mediterraneo (Livorno) e a un aeroporto internazionale (Pisa), al crocevia fra la direttrice tirrenica e l’asse anche ferroviario verso il nodo dell’Alta Velocità (con la risagomatura delle gallerie appenniniche a buon punto). Sì, manca ancora il completamento di alcuni tasselli del puzzle ferroviario, ma gran parte del disegno è già lì, sotto gli occhi…

Dalla Regione Toscana mettono nero su bianco le motivazioni di questo provvedimento: «Ricordiamo che l’attuale scenario energetico è condizionato dagli obiettivi internazionali e nazionali che impongono l’abbandono dell’attuale sistema energetico caratterizzato principalmente dall’approvvigionamento da fonti fossili». Inutile dire che la diffusione delle energie rinnovabili e, nel complesso, il tema della decarbonizzazione è «sempre più centrale a partire dall’adozione del “Green Deal” europeo del 2019». Non solo: attenzione anche al decreto del ministero dell’ambiente del 21 giugno 2024 (“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”) in base al quale è indispensabile assicurare il pieno conseguimento dell’obiettivo regionale al 2030 di «una potenza aggiuntiva pari ad almeno 4,25 gigawatt da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020».
Nell’informativa vengono sottolineati alcuni aspetti della “fotogafia” relativa alla Toscana: «La quota dei consumi finali lordi di energia coperta da fonte rinnovabile è attestata, nel 2022, al 17,9% (fonte: Gse “monitoraggio Fer Toscana” 2025), che è leggermente più basso della media nazionale».
Quanto ai consumi di energia, si rileva che la Toscana assorbe «circa il 6,3% della domanda di energia consumata a livello italiano». Così articolata:
- 1,5% dall’agricoltura,
- 25,6% dalle industrie,
- 16,7% dal terziario,
- 29% dai trasporti e mobilità,
- 27% dalle famiglie.
E ancora: «In Toscana, in linea con il dato nazionale, – viene fatto rilevare – il fabbisogno energetico è soddisfatto in larghissima parte grazie all’utilizzo di fonti fossili (solidi, petrolio e gas naturale) e circa l’80% della domanda finale di energia che a vario titolo arriva dalla collettività richiede queste tipologie di input primario:
il 4% dall’uso di combustibili solidi,
il 34% dall’uso del petrolio o di suoi derivati.
il 47% dal gas naturale,
il 18%, come detto, da fonti rinnovabili (solare, idrico, eolico, geotermia).
È centrale, lo vediamo, il fatto che il gas naturale contribuisce (direttamente o attraverso la generazione di energia elettrica) a «soddisfare quasi metà del fabbisogno complessivo regionale».
Il portavoce dell’opposizione, Alessandro Capecchi (Fdi), commenta così, secondo quanto viene riferito: «Ci si limita, sostanzialmente, ad individuare le aree di accelerazione per gli impianti fotovoltaici nelle aree di idoneità assoluta individuate nella bozza esaminata nella commissione congiunta Sviluppo economico e rurale e Territorio e ambiente. Non siamo in grado di fare atti di indirizzo, auspichiamo che laddove si voglia seguire il cronoprogramma, quanto elaborato ci venga trasmesso in maniera celere per recuperare la possibilità di esercitare il ruolo di indirizzo».