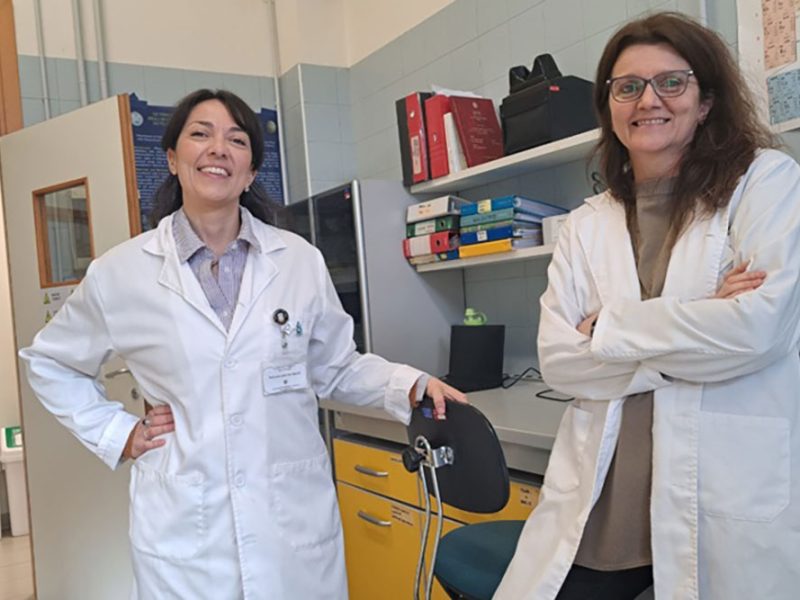Le foreste europee assorbono meno CO2: occhio alle conseguenze
L’ateneo fiorentino collabora a uno studio per porre rimedio agli effetti negativi

Il professore Giovanni Forzieri, UNIFI
FIRENZE. Le foreste europee non ce la fanno più: sono «sempre più sotto stress» e vedono ridursi la loro capacità di catturare anidride carbonica. È il preoccupato segnale che arriva da uno studio pubblicato su “Nature” al quale ha preso parte Giovanni Forzieri, studioso dell’università di Firenze (Dipartimento di ingegneria civile e ambientale).
Beninteso, non dobbiamo immaginare che, in un continente pur fortemente segnato dalla presenza dell’uomo, ormai le foreste siano sparite: al contrario, rappresentano il 40% del territorio dell’Unione Europea. Ma proprio il “funzionamento” naturale di queste grandi aree verdi è indispensabile per poter far camminare l’Europa verso la neutralità climatica, e c’è la possibilità di cambiare questa tendenza («le foreste d’Europa possono ancora costituire un pilastro della neutralità climatica ma il tempo per agire si sta riducendo: dobbiamo farlo adesso», dice il prof).
Dall’ateneo fiorentino – che sul proprio magazine rivendica l’impegno in questo campo – si mette in evidenza che «tra il 1990 e il 2022 le foreste europee hanno assorbito circa il 10% delle emissioni di carbonio legate alle attività umane, attraverso un processo noto come “carbon sink” (serbatoio di carbonio) e fondamentale per la riduzione della CO2 atmosferica». Questo “ingranaggio”, però, ora funziona peggio, e non è un dettaglio secondario: «Le foreste europee stanno catturando meno anidride carbonica», e questo «potrebbe compromettere gli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea». C’è bisogno di «interventi urgenti per invertire la tendenza», dicono da Firenze.
L’articolo di “Nature” si intitola “Securing the forest carbon sink for the European Union’s climate ambition” e riguarda uno studio guidato dal Joint Research Centre dell’Unione Europea (come dicevamo, ne è coautore Giovanni Forzieri, che nell’ateneo toscano è docente di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici)
Occhi puntati sul «declino del serbatoio di carbonio forestale»: se ne identificano le cause e si delineano le priorità di ricerca per migliorare il monitoraggio. È indispensabile una gestione forestale più attenta, «accompagnata da strumenti di osservazione avanzati», per riuscire a capire meglio «la capacità di assorbimento del carbonio, a aumentare la resilienza degli ecosistemi e a orientare politiche efficaci per proteggere questa risorsa vitale».
«I dati più recenti dell’Agenzia Europea dell’Ambiente indicano che il “carbon sink” forestale medio tra il 2020 e il 2022 è diminuito di circa il 27% rispetto al periodo 2010-2014», afferma Forzieri. «Le previsioni per il 2025 mostrano un quadro ancora più preoccupante, che rischia di allontanare l’Unione Europea dal traguardo di 42 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti di rimozioni nette aggiuntive entro il 2030, stabilito dal Regolamento 2018/841 sull’uso e il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura».
Perché si registra questa diminuzione nella capacità delle foreste di assorbire carbonio? Lo studioso del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale indica una serie di fattori che «riducono la crescita degli alberi, ne aumentano la mortalità e mettono sotto stress le foreste europee». Eccoli elencati:
- l’aumento dei prelievi di legname,
- la maggiore frequenza di ondate di calore e siccità dovute ai cambiamenti climatici,
- l’intensificarsi di incendi, tempeste e infestazioni di insetti.
Come affrontare il problema? Lo studio presenta un ventaglio di idee per «agire su più fronti»: 1) ridurre le emissioni di gas serra; 2) ripensare i regimi di taglio; 3) promuovere una gestione forestale che «renda i boschi più resilienti agli eventi estremi e alle nuove condizioni climatiche».
Ma c’è anche un altro aspetto da mettere nel conto: occorrono «strumenti di monitoraggio più tempestivi e dati affidabili sulla salute delle foreste e sui flussi di carbonio». A giudizio del prof fiorentino sono «indispensabili per definire politiche efficaci e misure pratiche in grado di ripristinare il serbatoio di carbonio e rafforzare la capacità di adattamento delle foreste». A ciò si aggiunga che «regolamenti aggiornati, incentivi alle pratiche sostenibili e una forte integrazione tra politiche climatiche e ambientali rappresentano le leve fondamentali per invertire la rotta».
«Un altro punto critico riguarda le lacune nelle conoscenze scientifiche», avverte il docente dell’università di Firenze: bisogna «misurare con maggiore precisione i flussi di carbonio tra suolo, vegetazione e atmosfera» . È una priorità, – tiene a sottolineare – così come lo è prevedere l’impatto degli eventi climatici estremi sul funzionamento del serbatoio: «Le tecnologie di osservazione satellitare ad alta risoluzione, integrate con dati raccolti sul campo e da piattaforme aeree, possono fornire un quadro più dettagliato e aggiornato dello stato delle foreste».
«Tuttavia – avverte – servono maggiore trasparenza e standardizzazione dei “dataset” già esistenti per valutarne al meglio gli impatti su biomassa, biodiversità e mortalità degli alberi. Anche la connessione tra biodiversità e resilienza è centrale: le foreste miste e più ricche di specie non solo tollerano meglio le perturbazioni, ma hanno anche un maggiore potenziale di assorbimento del carbonio».
Nell’articolo scientifico si segnala che occorre aprire gli occhi sulle «possibili conseguenze negative delle soluzioni basate sulla natura». Un esempio per tutti: è necessario analizzare «i possibili rischi, per i cicli idrici locali, collegati alla piantumazione di alberi su aree che in origine erano praterie, campi o zone aride, trasformandole così in aree forestali». Non solo: bisogna «integrare i modelli di crescita forestale con quelli socio-economici per comprendere come i prodotti derivati dalla raccolta influiscano sul bilancio del carbonio».