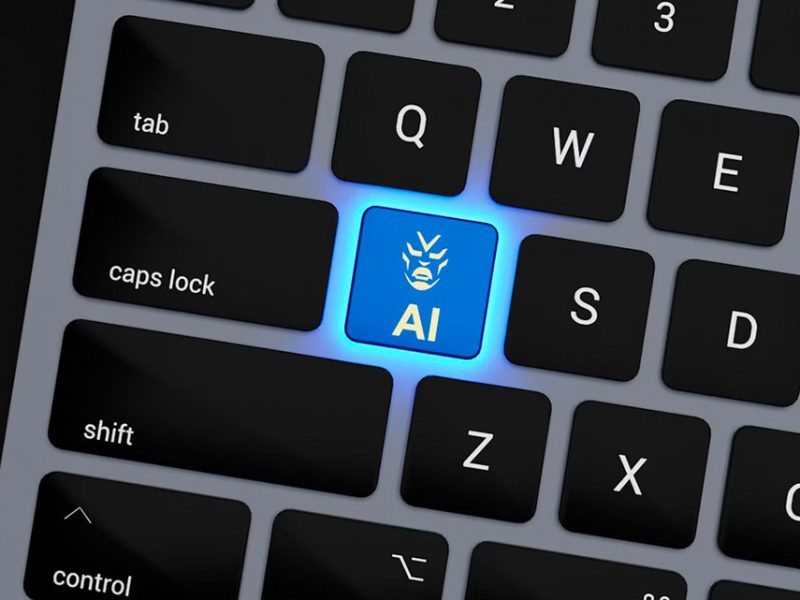L’acchiappa-onde ultratech di Cascina dà ragione a Stephen Hawking
A 10 anni dal primo “sussurro” gravitazionale. La scienziata di Colle che si sognava pallavolista

Nella campagna pisana fra Vicarello e Cascina i grandi bracci di Virgo che va a caccia di onde gravitazionali
GRECCIANO DI FAUGLIA (Pisa). Il segnale aveva viaggiato per 1,3 miliardi di anni per «raggiungerci alla velocità della luce, ma non era fatto di luce». Era una onda gravitazione, una sorta di sussulto dello spazio-tempo, che cent’anni prima l’intelligenza di quel geniaccio di Albert Einstein ha “immaginato” per la prima volta più che “scoperto”. Dunque, i dieci anni esatti che ci separano da quel giorno sono un singhiozzo, un batter di ciglia: eppure aver capito che così tantissimissimo tempo prima un’accoppiata di buchi neri si erano fusi ha rappresentato una novità da far accapponare la pelle.
Come dice il team di Virgo via Facebook per ricordare questa data storica: quell’onda gravitazione «non era un segnale speciale, ma uno come tanti che aveva sempre raggiunto il nostro pianeta. Quel giorno, però, per la prima volta, l’umanità era pronta ad ascoltarlo».
Ma non andate a cercare la notizia del secolo sui giornali del settembre 2015: non trovereste niente di niente. E mica per la proverbiale disattenzione della stampa per tutto quanto fa scienza: dipende dal fatto che è stato Ligo con entrambi i suoi acchiappa-onde, l’uno a Hanford non lontano da Seattle e l’altro a Livingston, Louisiana, dalle parti di New Orleans – a intercettare l’onda gravitazionale in quel giorno di fine estate di dieci anni fa esatti esatti: risulta che in quel momento l’impianto Virgo fra Vicarello e Cascina non fosse stato ancora del tutto messo in funzione e dunque non aveva le “orecchie” dritte quando si è sentito quel “whooop” destinato a mettere in fibrillazione la comunità scientifica. Per battezzarlo con un nomignolo lo hanno chiamato “Gw150914”. Peggio di Elon Musk che ha chiamato “X Æ A-Xii” uno dei figli…
Niente sui giornali perché la per quasi cinque mesi se ne stanno zitti zitti: è una équipe allargata eèèure nessuno si lascia scappare mezza parola, nemmeno per fare un po’ il ganzo. Eppure sapevano di avere in mano qualcosa che di lì a poco avrebbe portato al premio Nobel per la fisica (per Rainer Weiss, Barry Barish e Kip Thorne nel 2017). Ecco, a questo punto su quel “whooop” da “ricontrollare” entra in scena la collaborazione fra i pisani di Virgo e gli americani di Ligo e dopo una montagna di verifiche e controprove nel febbraio successivo arriva l’annuncio al globo terracqueo intero in galassiovisione.
DALL’ARCHIVIO: qui il link all’articolo del Tirreno in cui si racconta l’incontro con Lisa Barsotti, scienziata di Collesalvetti, al lavoro sulle onde gravitazionali al Mit di Boston (e nel 2018 premiata con l'”oscar della scienza”)
La prima cosa buffa: negli States a Ligo c’era Lisa Barsotti, una scienziata livornese di Collesalvetti che abitava a un paio di miglia dall’interferometro infilato nella nostra campagna toscana, lì ha conosciuto il suo “lui” (Matthew Evans) e insieme hanno varcato l’Atlantico per andare a lavorare all’acchiappa-onde del Massachusetts Institute of Technology (realizzato in tandem con il Caltech californiano: come una fusione fra Lakers e Celtics nel basket Nba…).
La seconda cosa forse ancor più buffa: Lisa Barsotti nel 2018 ha ricevuto il “Breakthrough Prize”, qualcosa che potremmo tradurre con “l’Oscar della Scienza”, in risposta al cronista che le chiedeva in cosa consiste il suo lavoro di scienziata, tira fuori una verve parecchio livornese: «Cosa faccio? Sto lì – il suo racconto in una intervista al “Tirreno” – e tutto quello che devo fare è tenere le orecchie dritte per sentire questo “whooop” che cambia il nostro modo di guardare l’universo: sì, è tutto qui. “Whooop” e basta». Poi per far capire com’è lo spazio in cui si muove la teoria di Einstein, la descrive come «un lenzuolo sul quale sono state gettate palline più o meno grosse che lo deformano e si attirano causando ulteriori deformazioni a questo lenzuolo-spazio». Ma la Lisa ragazzina di Colle di tanti anni fa, scienza a parte, cosa sognava di diventare? «La pallavolista, eccome se mi sarebbe piaciuto».

Il disegno della torta con le 10 candeline dell’anniversario della prima volta in cui è stata ascoltata una onda gravitazionale: Virgo di Grecciano (Fauglia) lo raffigura così perché lo spazio non è come sembra…
«È la conferma diretta di una delle predizioni più affascinanti della teoria della relatività generale di Einstein, l’idea che nello spaziotempo possano propagarsi minuscole increspature che viaggiano alla velocità della luce e attraversano la materia indisturbate: le onde gravitazionali»: è quanto scrive sul “Tirreno” il prof. Giovanni Losurdo, professore di fisica sperimentale alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Lo scienziato ricorda il contributo che a questa scoperta è stato dato «dal contributo del fisico Adalberto Giazotto e della sua scuola pisana» e sottolinea che l’interferometro Virgo, situato a Cascina (Pisa), è «un pilastro nella rete mondiale di rivelatori e, nell’agosto 2017, ha permesso di localizzare con precisione nel cielo la fusione di due stelle di neutroni». Aggiungendo poi: «Quattrocento anni dopo che Galileo aveva rivolto il cannocchiale al cielo dando inizio all’osservazione scientifica dell’universo, è nata la nuova astronomia multimessaggera con onde gravitazionali».
Spalancare la porta della conoscenza delle onde gravitazionali – è ancora il prof. Losurdo a scriverlo sul quotidiano livornese – ha trasformato «un’idea matematica di Einstein in uno strumento per indagare il cosmo. Siamo solo all’inizio di questa esplorazione che promette scoperte sorprendenti: ancora non comprendiamo la natura del 95% dell’universo, né come conciliare la teoria della gravità con quella delle particelle elementari. Le onde gravitazionali ci aiuteranno a dare risposte a queste domande fondamentali».
Adesso le apparecchiature ultra-high tech di Virgo più le “gemelle” Ligo negli Usa e il Kagra in Giappone – in sigla li hanno chiamati “Lvk” – lavorano insieme: con la loro rete che intercetta le onde gravitazionali, ha “acchiappato” «un totale di oltre 300 fusioni di buchi neri, la maggior parte delle quali sono già confermate mentre altre attendono ulteriori analisi». Questo enorme incremento delle rilevazioni viene attribuito al perfezionamento delle tecnologie: l’ingegneria di precisione quantistica è tale da riuscire a compiere le misurazioni più precise mai esiste. Per percepire le distorsioni spazio-temporali indotte dalle onde gravitazionali occorre avere strumenti di eccezionale sensibilità: devono rilevare cambiamenti nello spazio-tempo «inferiore a un decimilesimo della larghezza di un protone. E stiamo parlando di qualcosa che «è 700 trilioni di volte più piccolo della larghezza di un capello umano». Settecento trilioni: settecentomila miliardi di volte più volte, capito?
Dal quartier generale di Virgo non si limitano a spegnere le dieci candeline sulla torta e campar di gloria: spiegano che «la maggiore sensibilità degli strumenti» è controprovata da quanto scoperto quando è stata rilevata il 14 gennaio scorso una onda gravitazione abbastanza simile a quello del settembre 2015: buchi neri in scontro frontale a circa 1,3 miliardi di anni luce da noi; masse superiori di 30-40 volte a quella del nostro Sole. L’avanzamento delle tecnologie hanno reso possibile sentire “Gw250114” in modo «forte e chiaro, e questo ci permette di testare le leggi fondamentali della fisica», come dicono Katerina Chatziioannou e William H. Hurt.
Proprio da questo recente episodio – affermano dal centro di ricerca alle porte di Cascina – è stato possibile “vedere” le prove del teorema dell’ “area del buco nero”, un’idea di Stephen Hawking datata 1971. Dicimo che a spanne potremmo riassumerla così: quando i buchi neri si fondono, aumentano la superficie e perdono anche energia sotto forma di onde gravitazionali. L’iniziale superficie complessiva dei due buchi neri distinti pari a 240mila chilometri quadrati («all’incirca le dimensioni del Regno Unito») si è ritrovata successivamente, dopo la fusione, pari a 400mila chilometri quadrati («quasi la dimensione della Svezia»).

DALL’ARCHIVIO: qui il link all’articolo con cui la Gazzetta Marittima ha raccontato il complesso high tech di Virgo costruito nella campagna pisana alle porte di Collesalvetti, fra Vicarello e Cascina, alle porte dell’abitato di Grecciano (Fauglia)
Il premio Nobel Kip Thorne ricordato che, dopo la notizia del 2015, Hawking gli aveva telefonato per capire se le novità confermasse il suo teorema. Hawking è morto nel 2018 e non ce l’ha fatta a vedere le osservazioni verificare la sua teoria: «Se Hawking fosse vivo, si sarebbe divertito a vedere l’area dei buchi neri aumentare con la fusione», afferma Thorne.
Secondo quanto confermato dall’équipe di Virgo, nel futuro immediato gli scienziati dell’alleanza “Lvk” conta di aggiungere al gruppo un altro rilevatore, stavolta in India, e di compiere un ulteriore miglioramento delle capacità delle apparecchiature. Ad esempio, il progetto europeo (Einstein Telescope) prevede – si afferma – di «costruire uno o due enormi interferometri sotterranei con bracci di oltre 10 chilometri», quello statunitense (Cosmic Explorer) sarebbe «simile all’attuale Ligo ma con bracci lunghi 40 chilometri». Gli studiosi dicono che con osservatori di questa scala si potrebbero «ascoltare le prime fusioni di buchi neri nell’universo e, forse, l’eco dei tremori gravitazionali dei primissimi momenti del nostro universo».
«Questo è un momento incredibile per la ricerca sulle onde gravitazionali: grazie a strumenti come Virgo, Ligo e Kagra, possiamo esplorare un universo oscuro che in precedenza era completamente inaccessibile», afferma Massimo Carpinelli, professore presso l’Università di Milano Bicocca e direttore dell’Osservatorio europeo di Cascina: «I risultati scientifici di questi dieci anni stanno mettendo in moto una rivoluzione nella nostra visione dell’Universo. Stiamo già preparando una nuova generazione di rilevatori: in Europa l’Einstein Telescope; negli Usa il Cosmic Explorer. Così come l’interferometro spaziale Lisa: ci aiuterà ad andare ancora più lontano nello spazio e più all’indietro nel tempo. Una sempre più ampia e solida cooperazione tra scienziati, paesi e istituzioni, tanto su scala europeo che a livello globale, ci permetterà nei prossimi anni di affrontare queste sfide straordinarie».

Lo scienziato inglese Stephen Hawking, morto nel 2018
- Dietro Virgo c’è una galassia di un migliaio di persone che vengono da una ventina di Paesi, soprattutto europei: l’apparecchiatura acchiappa-onde è finanziato da: per la Francia il Cnrs (polo per la ricerca scientifica); per l’Italia l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; per i Paesi Bassi l’Istituto Nazionale di Fisica Subatomica (Nikhef); per il Belgio il Fwo (una fondazione delle Fiandre) e il Fondo belga per la ricerca scientifica
- Ligo è in mano all’agenzia governativa statunitense e l’ha dato in gestione, come detto, al Caltech (una sorta di politecnico californiano privato di Pasadena) e al Massachusetts Institute of Technology (il mitico Mit di Biston). Da allargare al sostegno tedesco (Max Planck Society), britannico (Science and Technology Facilities Council) e australiano (Australian Research Council): in ballo un esercito di 1.600 scienziati di ogni angolo del mappamondo.
- Kagra è il nome dell’interferometro laser con braccio lungo 3 chilometri di lunghezza nelle miniere della compagnia Kamioka, nella zona di Gifu, Giappone centrale. Al lavoro 400 studiosi provenienti da 128 istituti in 17 paesi o regioni.